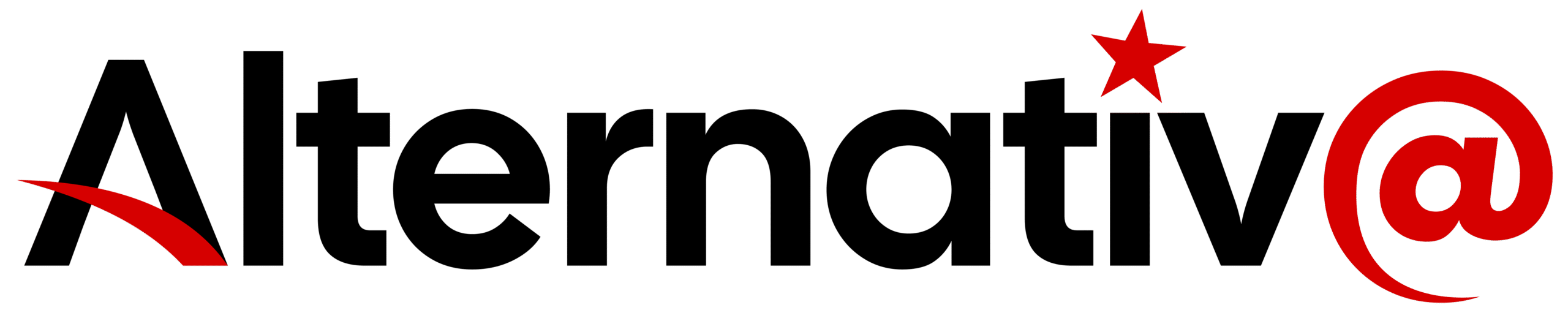Tratto da Osservatorio Repressione
di Andrea Valdambrini, Francesco Vignarca*
La spesa militare dei Paesi dell’Unione europea sta per toccare il traguardo dei 6.800 miliardi. La Commissione Europea moltiplica per otto gli 800 miliardi del Rearm. Il 90% del costo ricade sui bilanci nazionali, a scapito della spesa sociale. Mangeremo e ci cureremo con le armi. Il riarmo non è più semplice «deriva» militarista, ma scelta politica lucidamente brutale, e pericolosa, sulle spalle dei popoli europei
Eccola la roadmap per la difesa presentata dalla Commissione Ue nella scadenza annunciata, giusto a una settimana dal prossimo vertice dei capi di stato europei a Bruxelles al cui tavolo sarà Von der Leyen a presentarla. Nella scansione delle tappe del piano bellico firmato dalla presidente della Commissione, gli obiettivi prefissati mostrano come l’esecutivo Ue si proietti in avanti prospettando una spesa record per il riarmo. Ma facendo due precisazioni importanti: una sulla leadership europea nel riarmo, l’altra sulla Nato, da cui è evidentemente dipendente.
LA DIFESA COMUNE viene considerata come il pilastro della politica estera comune, che però non c’è perché resta nelle mani degli stati membri (e infatti il cancelliere tedesco Merz assicura che la Germania avrà l’esercito più forte tra quelli europei). La strada per arrivarci sembra lunga e tortuosa. La roadmap non fa che confermarlo: la via maestra è nella capacità industriale, veicolata dalla spesa in armamenti.
L’Ue ha già aumentato i suoi investimenti, passati da 218 a 392 miliardi negli ultimi quattro anni. Sono numeri forniti dalla vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen, che indica un importo quasi raddoppiato, presumibilmente a scapito di altri capitoli considerati meno prioritari. La cifra è già importante, però non basta alle ambizioni di Bruxelles. Il commissario alla Difesa Andrius Kubilius prevede un big bang nei fondi per la difesa con investimenti per quasi settemila miliardi entro il 2035. E riprendendo un’idea che circola da tempo nei palazzi Ue, aggiunge che per finanziare le armi si potrebbero, ad esempio, usare anche i fondi non spesi del Pnrr, per un valore di 300 miliardi di euro.
SE «È ARRIVATO il momento di trasformare la potenza economica dell’Europa in forza militare», come chiarisce la responsabile della politica estera Kaja Kallas, la roadmap lo fa partendo dai mattoni che vengono chiamate «coalizioni di capacità». Quello delineato dalla Commissione è uno scenario in cui gli stati si mettono insieme, in gruppi più o meno piccoli, per realizzare progetti di difesa nei settori chiave. Questi ultimi vengono indicati in quattro iniziative faro, ovvero la difesa con i droni, l’osservatorio sul fianco orientale, lo scudo aereo e quello spaziale. Già nella formulazione, si tratta di priorità molto più sfaccettate rispetto alla proposta iniziale del «muro di droni», dopo le critiche che Von der Leyen ha ricevuto da molti leader europei. E poi, la formazione delle coalizioni, dettaglia ancora la roadmap, dovrà partire dai primi mesi del 2026, quando ci sarà anche da decidere il formato, con i paesi che guideranno tutto il processo di riarmo in vista del 2030, limite fissato per la strategia di «preparazione» (già «riarmo», ora di nuovo passata sotto l’eufemistico contenitore «preservare la pace»), concepita sia in funzione anti-Putin che come adattamento storico alla nuova era dei rapporti transatlantici inaugurata da Trump.
Eppure, questa roadmap sembra più avere il carattere dell’indicazione che quello di decisione pienamente guidata da Bruxelles. Nei giorni scorsi la Commissione ha dovuto abbassare le sue preteste dirigiste nell’ambito della difesa, dopo le proteste di molte capitali, gelose delle prerogative nazionali in materia.
PALAZZO BERLAYMONT fa marcia indietro, ritagliandosi comunque un ruolo di coordinamento delle politiche di riarmo. Così l’agenzia europea della difesa, gestita dagli stati membri, avrà un ruolo centrale nel facilitare le coalizioni tra paesi, mentre alla Commissione Ue spetterà garantire il collegamento tra le stesse coalizioni e le politiche di finanziamento Ue. La roadmap si avventura comunque in un’altra importante indicazione di Bruxelles alle capitali, che riguarda l’entità della spesa. Entro il fatidico 2030, gli acquisti congiunti tra stati europei dovrebbero arrivare almeno al 40% del totale, raddoppiando così rispetto all’attuale 20%. Inoltre, almeno il 55% degli investimenti dovrà andare ad industrie europee, con l’intento di favorire la crescita di un settore industriale su cui molti paesi Ue, a partire dalla Germania, ripongono non poche speranze.
La clausola buy european – voluta dalla Francia, avversata da Polonia, Germania e Italia tra gli altri – è quella su cui si gioca il rapporto con Washington. Ed è in merito al rapporto con gli Usa, azionista di maggioranza della Nato, che la Commissione deve di nuovo chiarire. Non c’è nessun intento di raddoppiare, né tantomeno di sostituire il ruolo dell’Alleanza Atlantica, piuttosto «ci stiamo completando a vicenda», ha dichiarato mercoledì sera Kallas dalla riunione dei ministri della Difesa dei 27 a Bruxelles. Impossibile non ricordare che la richiesta agli europei di spendere di più in armi era arrivata direttamente da Trump.
Economia di guerra permanente
Non è un fantasma, è un Moloch quello che attraversa l’Europa e ne ipoteca il futuro. È la militarizzazione del discorso politico e dell’economia.
Comincia ormai a determinare scelte e decisioni di lungo periodo, preparate e rese «naturali» da una retorica martellante che trasforma la paura in consenso e l’industria militare in futuro inevitabile. Non più semplice «deriva» militarista, ma scelta politica lucidamente brutale, e pericolosa, sulle spalle dei popoli europei.
Siamo di fronte – ce lo dicono i dati, oltre che gli annunci – a un riarmo strutturale, pianificato e non solo a una congiuntura passeggera contraddistinta da aumenti della spesa militare. Nel 2021 la spesa militare complessiva dei Paesi Ue era di 218 miliardi di euro, nel 2024 è salita a 343 miliardi e le previsioni consolidate per l’anno in corso si attestano sui 392 miliardi (molto vicini alla soglia psicologica dei 400). Già questo basterebbe a mostrare che il presunto «sottofinanziamento della difesa» agitato da Commissione e Consiglio Ue è una costruzione ideologica. Non solo perché la spesa militare è già oggi ai massimi storici e cresce più di qualsiasi altro capitolo di bilancio pubblico, ma perché viene fatta passare l’idea che per difendersi occorra armarsi. Mentre il modo migliore per costruire una vita collettiva più sicura è quello di garantire diritti e lavorare all’attenuazione dei conflitti.
La vera portata del militarismo europeo si coglie dando uno sguardo al futuro che viene tratteggiato. Kubilius, Commissario Ue alla Difesa, è stato esplicito: «Noi europei investiremo entro il 2035 circa 6.800 miliardi di euro nel comparto militare, con il 50% che confluirà nell’acquisto di armamenti: sarà un vero big bang finanziario». E ha chiarito che il 90% del peso ricadrà sui bilanci degli Stati membri. Perché l’obiettivo vero non è per nulla una strutturazione definitiva dell’Unione anche sul piano militare e di difesa, ma è quello di avvantaggiare gli interessi armati. Lo dimostra anche l’ennesimo cambio di nome del piano di riarmo della commissione, che con l’ultima operazione cosmetica è stato presentato come Preserving Peace-Defence Readiness Roadmap 2030 (ancora una volta il richiamo mistificatorio alla Pace serve a convincere opinioni pubbliche che sono refrattarie a richiami bellicisti). Ad ogni step si cambia nome per renderlo più vendibile, ma la sostanza resta: costruire un’Europa armata prima ancora di costruire una vera politica estera comune. Che dovrebbe essere l’unica strada logica e sensata, anche per chi vuole una «Europa forte» sul versante militare. Invece, prima gli strumenti della guerra, poi – forse, un giorno – la politica. Un’inversione logica e democratica che favorisce un solo soggetto: i produttori di armi.
Perché questo è il punto: l’accelerazione non è pensata per la difesa dei popoli europei, ma per alimentare i profitti. Lo dimostrano anche i programmi già attivi – come l’European Defence Fund o il programma Asap – nonché gli stessi i dati di Bruxelles: questi strumenti non hanno portato alcuna integrazione reale della produzione bellica europea. Ogni Paese continua a comprare e produrre per sé, seguendo logiche di piccolo potere e influenze di piccoli interessi industriali, frammentando il mercato e rimanendo succube della preminenza tecnologica Usa.
Questa corsa folle viene giustificata con la paura di minacce esterne agitate a comando per sospendere il pensiero critico e azzerare il dibattito democratico. Ma è un inganno. Perché quella che chiamano «difesa» è solo architettura militare, mentre la difesa reale – sociale, civile, diplomatica, energetica, informativa – non viene nemmeno discussa. E soprattutto perché ogni miliardo speso oggi in armi è un miliardo sottratto alla scuola, alla sanità, alla riconversione ecologica, alle politiche sociali. Si chiama economia di guerra permanente.
La società civile attiva per la pace e per il disarmo lo denuncia da anni: l’aumento degli investimenti militari non porterà più sicurezza, ma più instabilità e più crisi. E soprattutto ipotecherà il futuro: il riarmo europeo è costruito con debito pubblico e vincoli di spesa pluriennali, che passeranno come un cappio ai prossimi governi e alle prossime generazioni. Di fronte a questo salto quantico forse non basta più solo monitorare o denunciare: servono alternative strutturali alla guerra. Servono politiche di sicurezza non armata e difesa civile europea. Serve una diplomazia autonoma e multilaterale. Serve disinnescare la centralità dell’industria bellica nell’economia europea. Perché non è vero che non ci sono alternative. Il problema è che non si vogliono discutere.
Quello che ci aspetta non è una parentesi. È un bivio storico. O lasciamo che l’Europa si trasformi in una fortezza armata al servizio dei profitti militari, o costruiamo un altro modello di sicurezza. Che parta dalle persone, non dalle armi.
*da Il Manifesto