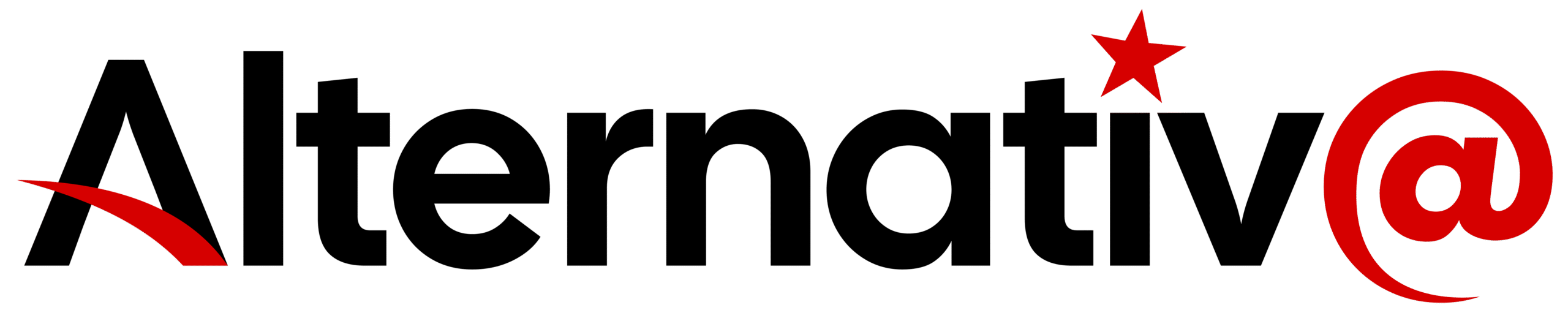Partiamo dall’alto, dalla sommità dell’Etna; e poi scendiamo a valle, a Catania.
Qualche settimana fa una notizia imprevista e sbalorditiva, anche se anticipata da piccoli segnali, scuote la comunità etnea: i Crateri Silvestri, il più raggiungibile dei siti che punteggiano le pendici dell’Etna, “consumato” dalle suola di migliaia di visitatori, incredibilmente proprietà privata di un potente imprenditore locale, che controlla anche il sistema delle ascensioni ai crateri sommitali, sono visitabili dietro congruo pagamento di un biglietto. Finora nessuna reazione dell’ente Parco (che c’è, ma non si vede), voci sorprese e impotenti si sollevano da parte di qualche Comune e delle Associazioni ambientaliste. La Regione si muove a passi felpati e lenti. Siamo al grottesco: un sito Unesco proprietà privata, con ingresso a pagamento!
Ma mentre scoppia questa grana, apprendiamo che due deputati regionali della DC cuffariana (un pezzo del grande e molle centro politico, volàno degli interessi affaristici regionali), hanno presentato un ddl che propone un generale innalzamento altimetrico dei limiti del parco. I due deputati, Giuffrida e Pace, non sono certo dei buontemponi, anche se le motivazioni che adducono nella relazione (dalla sintesi giornalistica su “La Sicilia” del 22.10.25) sarebbero divertenti boutades se non fossero alimentate da cospicui e diffusi interessi e coperti da una “visione” della quale il consumo di suolo è l’unica stella polare. La parte grottesca della relazione è quella in cui i due deplorano la recessione economica del territorio etneo, lo spopolamento, la disoccupazione giovanile, la crisi generale dell’economia, e così via: come se questi fenomeni, generalizzati soprattutto nella aree interne, fossero causati dall’istituzione del Parco dell’Etna! Si lamenta anche l’impossibilità di svolgere attività agricole. Il che è falso: esse sono consentite, sia pure con limitazioni, e sembrano leggermente impossibili nelle aree sommitali, oltre quota 1800-2000, visto che l’Etna, come tutti sanno, tranne i proponenti, è un vulcano attivo.
I reali interessi trapelano se si scorre il resoconto: i vincoli burocratici, il mostro che frena lievemente gli appetiti speculativi di alacri imprenditori, e che costituiscono l’esistenza e la ratio di un Parco, comporterebbero l’impossibilità di costruire strade e magazzini, il blocco dell’edilizia con 20.000 progetti in attesa di autorizzazione e altri orrori (premono interessi che reclamano ulteriori vie d’accesso ai crateri). Si imputano all’esistenza del Parco (e non all’assenza di strumenti e volontà di controllo e repressione e alla drammatica mancanza di personale) perfino le discariche abusive che deturpano l’ambiente, le quali sparirebbero, evidentemente, se i vincoli fossero meno stringenti. Ah, il sogno di un ulteriore Paese dei Balocchi! Un disegno neo-trumpiano di trasformare un parco naturale in un parco divertimenti! La via della salvazione passerebbe in sostanza da un generale innalzamento del perimetro a quota 1.100 metri; in tal modo si potrebbe allegramente cementificare e bitumare un bel po’ di territorio: questa è la cultura antropologica ed economica della proposta.
Ma quel che accade in alto si spiega solo se si parte dal basso, ossia dal luogo in cui si origina la «valanga che sale»: espressione che ha reso famoso un generale siciliano, Antonino Cascino, che così guidava i suoi fanti nel corso della Grande Guerra. La valanga è, naturalmente quella del cemento&asfalto, da sempre in moto nelle infelici plaghe etnee (e non solo), e che parte da Catania, la presunta «Milano del Sud» degli anni Cinquanta e Sessanta. Complice la sua posizione baricentrica, retta da un ceto politico mediocre e avido, la città, provinciale e popolare, ha man mano sviluppato una identità affaristica di basso livello, centrata sull’edilizia forsennata e devastante, che ha avuto un suo momento di gloria nel catastrofico sventramento del centro storico, attorno al 1960. Accanto a un presunto centro direzionale è rimasto, fino ad oggi, un cratere in attesa di saturazione, centro di interessi fondiari e finanziari. Da lì sono nati i Cavalieri del lavoro, narrati e denunciati da Giuseppe Fava, da lì l’invivibilità quotidiana, da lì una vocazione permanente alla speculazione edilizia che ha condizionato la piccola zona industriale, di fatto al servizio dell’edilizia e del commercio, l’altra grande vocazione “moderna” della città, in fondo il vero collegamento con le tendenze della creativa urbanistica milanese. La classe politica cittadina, quasi sempre conservatrice e di destra, non può che rifletterne la composizione sociale. La miseria cresce e dilaga nelle periferie, i giovani scappano via, e tutto il contorno si può immaginare. Ma la stagione della speculazione sembra non finisce qui. In direzione dell’Etna sono stati occupati i terreni, una volta floridi e ameni, dei paesi etnei, anch’essi devastati dalla valanga di cemento, asfissiati dal traffico, dai localini rumorosi e dai funerei Centri Commerciali. E la famelica orda speculativa non dà segno di volersi fermare. Infinite sono le proposte di “ammodernamento e sviluppo”, ossia di ulteriore cementificazione e valorizzazione che adesso prende di mira quel che resta della costa, spingendosi verso Nord e verso Sud, fino ad Augusta, con megaprogetti che riguardano i porti, nuovi insediamenti turistici e commerciali: è la faccia capitalistica della trasformazione, gestita da finanza e grande impresa; e, nella città, dilaga una “gentrificazione” stracciona, una trasformazione dei quartieri popolari in slum per turisti ignari, sbigottiti e presto in fuga: non senza aver tentato, naturalmente, un piccolo tour sull’Etna, fornito da miriadi di piccole e medie imprese del settore, che trovano ai cancelli dei Crateri Silvestri il loro sublime compimento.