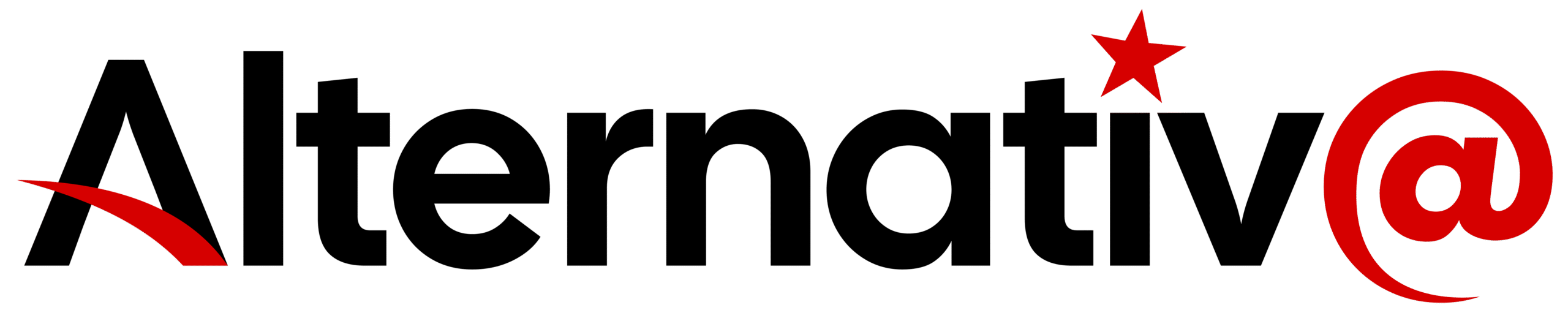Le piazze stracolme per la Palestina sono state un riscatto di dignità, una rottura della cappa asfissiante della passività, una ribellione al senso di impotenza. Per la Palestina, per noi, per il futuro blindato in un neoliberismo autoritario chiuso nell’orizzonte della solitudine, della guerra, della devastazione ambientale.
È stato uno scatto di umanità, ha dato sostanza ad un diritto ignorato, e violato; violato con la protervia di chi rivendica la violazione o mente spudoratamente: dai doppi standard alle accuse di antisemitismo, al genocidio, alla fame impunemente utilizzate come arma di guerra, al sequestro di persona e al trattamento inumano degli equipaggi della Global Sumud Flottilla.
È stata una scossa maturata in fretta, quasi improvvisa, dopo anni in cui il silenzio pesantissimo e accuse denigratorie additavano i pochi che avevano osato sin da subito prendere voce, studentesse e studenti. Non a caso oggi, le università sono tra i nemici ed è in Parlamento un disegno di legge, il c.d. ddl Gasparri, che, sotto la mistificazione dell’antisemitismo, proprio le proteste in scuola e università vuole punire e impedire, arrivando ad identificare antisionismo e antisemitismo, a prevedere la delazione (pena punizione), sospensioni, decadenze e formazione obbligatoria (un vero e proprio disciplinamento).
E ora, dopo la scossa? Qual è il rapporto fra movimenti e democrazia? E fra movimenti e classe? Qual è la relazione fra movimenti e istituzioni? E, infine, come continuare?
Movimenti e democrazia
Le piazze stracolme ci hanno ricordato, chi è il soggetto della democrazia, dei diritti, del diritto (dalla parte giusta della storia): le persone e i popoli.
Ci hanno ricordato che dire no è possibile, si può, in certe circostanze si deve; che il dissenso in una democrazia è necessario; che dire no, che, come ricorda Camus, è anche un dire sì, un prendere posizione.
Le piazze sono un grido contro l’esistente, e insieme, contro la spoliticizzazione, intesa come perdita del senso del collettivo, della comunità, e il desiderio di trasformazione dello stato di cose.
Sono un atto contro la solitudine e la paura (come terreno del capo e della deriva autoritaria), contro la percezione di ineluttabilità, di impotenza e di mancanza di futuro.
È una ripresa della politica, se pur nelle forme della democrazia dal basso e non della democrazia istituzionale, rappresentativa. È il potente movimento delle masse che rivitalizza la democrazia, di cui ragiona Rosa Luxemburg.
Movimenti e conflitto sociale
I movimenti esprimono conflitto sociale, si situano nello spazio della politica, in implicita opposizione, dunque, ad un potere che si pone come “assoluto” e unico, spoliticizzato, come il dominio neoliberista e la logica omologante della guerra.
I movimenti esercitano conflitto sociale, se pur in forme diverse rispetto a quelle “classiche”, quali le lotte operaie.
I movimenti sociali veicolano una conflittualità “nuova”, si situano lungo le faglie che in un contesto dinamico si aprono nel terreno del conflitto sociale; in questo senso, i movimenti costituiscono la cartina di tornasole delle trasformazioni e delle tensioni che attraversano la società, molto spesso sono la prima voce a rivendicare diritti in fieri, evidenziare contraddizioni, esprimere bisogni, ovvero sollevare un conflitto.
Ancora. La stessa esistenza di un movimento, come accennato, con la partecipazione in prima persona, la ricostruzione di legame sociale contro l’atomizzazione della società, è un atto contro la gabbia del dominio neoliberista, è conflitto sociale agito dal basso.
I movimenti, dunque, restituiscono vitalità alla democrazia nel loro esercitare partecipazione effettiva, esercitano e rivendicano libertà e diritti riconosciuti dalla Costituzione; fungono da antidoto alla sterilizzazione del pluralismo e del dissenso che della democrazia costituiscono l’essenza e allo scivolamento in una «confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà» (Marcuse).
Sono spesso i movimenti sociali ad assumere come propri i valori e il progetto della Costituzione, in opposizione a scelte politiche dei governanti inserite nel quadro della governamentalità neoliberale: i movimenti esercitano una “resistenza costituzionale”.
Non è un caso che dai furgoni dei cortei si citasse il diritto internazionale, si ricordassero i diritti e i limiti del potere, anche bellico.
Certo, mancano organizzazione e stabilità.
Movimenti e istituzioni
E qui arriva il discorso sulle istituzioni: il rapporto dei movimenti con le istituzioni.
È un rapporto che può essere rivendicativo, oppositivo, di indifferenza o di netto rifiuto. Entra in gioco anche la mancanza di un riferimento politico nel circuito politico-rappresentativo, che fermo restando l’autonomia e l’indipendenza dai movimenti, sappia recepirne istanze e rivendicazioni.
La considerazione che vorrei proporre però è questa: il movimento non è partito, è altro, e deve restare altro. La democrazia è un fenomeno complesso, movimenti autorganizzati vitali ne sono una componente essenziale.
Come continuare
L’importanza dei movimenti resta, in ogni caso, ma, pensando al futuro, a come mantenere la mobilitazione, entrano in campo due parole, che possono essere utili per continuare, per connettere la ricchezza di associazioni e persone che sono scese in piazza: trasversalità e convergenza.
Questo, nella consapevolezza che la forza dei movimenti può perdersi, essere meramente esplosiva, effimera, come, d’altro canto, è un rischio anche la possibilità di perderne l’essenza nell’istituzionalizzazione o nella burocratizzazione, così come nel settarismo, nelle divisioni, per stanchezza, o per la repressione.
Trasversalità e convergenza possono aiutare a continuare con grandi momenti di forza collettiva, ma anche – direi soprattutto – nel quotidiano, nei mille rivoli in cui si articola il conflitto sociale, sui territori.
Trasversalità
I movimenti, ad esempio quelli territoriali, come il movimento No Tav, ci insegnano come attraverso i movimenti possa comparire una classe in sé, che acquisisce sempre più la consapevolezza di essere una classe anche per sé, ovvero raggiunge «la coscienza che i propri interessi corporativi, nel loro sviluppo attuale e avvenire, superano la cerchia corporativa… e possono e debbono divenire gli interessi di altri gruppi subordinati» (Gramsci).
Si assiste ad un “salto in generalità”, con la maturazione di consapevolezza politica, la capacità di collegare locale e globale, di cogliere le connessioni e le ragioni attraverso una chiave di lettura complessa e complessiva.
Come racconta Celerina (classe 1940), sarta prima dei quattordici anni, operaia alla FIAT, partecipante al movimento no Tav: «io mi scaldo per tutte le cause sulla libertà» o, come osserva un’altra partecipante, Mira: «la nostra lotta… non è solo una lotta contro il treno, ma è una lotta contro l’oppressione di una certa parte del mondo verso un’altra che ha meno voce».
La trasversalità concerne ad un tempo la composizione dei movimenti, le rivendicazioni (la vicinanza tra rivendicazioni, la convergenza con altre lotte) e le pratiche.
Emerge una “classe in senso trasversale”: non vi è una composizione di classe in senso tradizionale, ma in quanto si sta da una parte nel conflitto sociale, nella contrapposizione fra chi governa e trae benefici dal finanzcapitalismo e dalla guerra e chi ne è soggetto e subisce gli effetti di un mondo sempre più diseguale e mercificato. In questo senso i movimenti possono essere definiti come movimenti di classe.
Convergenza
La trasversalità, il “salto in generalità”, hanno uno sbocco quasi naturale nella convergenza; per chiarire cosa si intende, si può muovere da una citazione di una realtà esemplare. Gli operai della Gkn in lotta chiedono a chi li incontra «Voi come state?»; è un porsi immediato nella prospettiva di un «“Insorgiamo”» come «messaggio responsabilizzante e collettivo».
È una convergenza che coinvolge sia il territorio: «abbiamo visto la fabbrica fondersi con il territorio… abbiamo visto una comunità insorgere, solidarizzare, autorganizzarsi»; sia altre lotte e che muove dalla consapevolezza dell’interdipendenza e intersezionalità delle lotte.
Come afferma un partecipante al movimento no Tav: «Non ha senso partecipare alle manifestazioni qui [n.d.r.: Val Susa; movimento no Tav] ma non riportare poi nel tuo posto il fuocherello che possa far partire una lotta».
La sinergia dei movimenti, nella pluralità dei loro obiettivi, delle loro azioni, delle persone che li fanno vivere, propone e pratica alternativa, collega giustizia sociale e ambientale, rendendo evidente come si tratti di declinazioni diverse dello stesso conflitto (sociale), in coerenza con un costituzionalismo emancipante che tiene insieme i differenti profili della democrazia, politica, economia e sociale. A tutti noi il lungo e assiduo lavoro di continuare a invertire la rotta.
*Alessandra Algostino, giurista