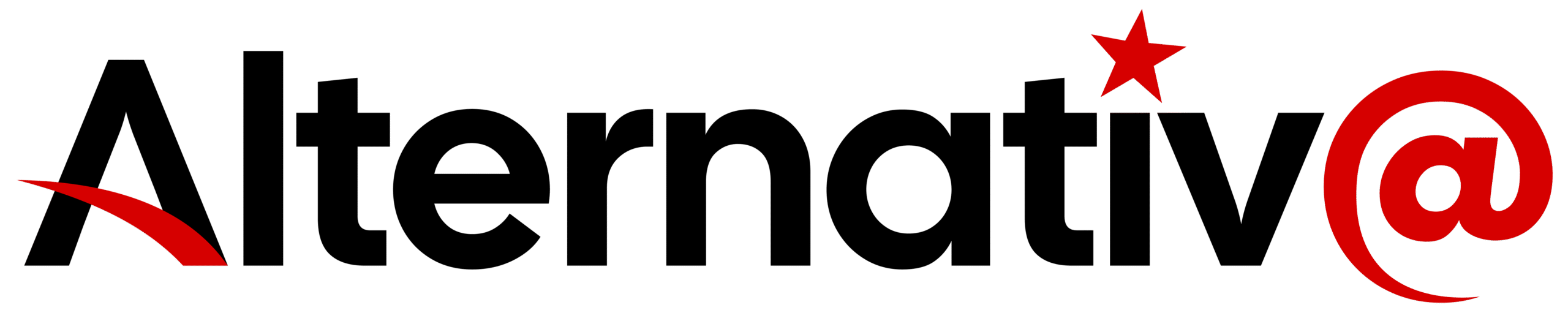Francesco Chiodelli, professore associato di geografia economica e politica presso l’Università di Torino, autore di “Cemento armato. La politica dell’illegalità nelle città italiane” (Bollati Boringhieri, 2023)
Alberto Deambrogio: Lo spirito bipartisan, già visibile nelle vicende dell’urbanistica milanese, riemerge chiaramente anche a Torino, dove il Comune di centro sinistra chiede più coraggio nelle semplificazioni normative per il Piano Regolatore alla Regione di centro destra. Al centro c’è sempre la cosiddetta rigenerazione urbana. Tu che idea ti sei fatta di tutto questo?
Francesco Chiodelli: Non conosco sufficientemente le vicende dell’urbanistica torinese per potermi esprimere in proposito. Tuttavia, credo che, con le dovute contestualizzazioni, il caso di Milano possa essere significativo anche in relazione ad altri contesti. Come noto, la vicenda relativa al Salva-Milano ha visto una “inedita” convergenza fra le forze politiche di centro-sinistra, che governano il capoluogo lombardo e che hanno fortemente caldeggiato una legge nazionale che risolvesse i problemi milanesi, e le forze politiche di destra in parlamento, che si sono fatte promotrici di un disegno di legge nazionale colloquialmente definito, per l’appunto, “Salva-Milano”. Tale disegno di legge avrebbe dovuto stabilire una “interpretazione autentica” di alcune norme urbanistiche che il Comune di Milano aveva interpretato in passato in modo estremamente criticabile – o meglio, a parere della magistratura, illegittimo, dando così luogo a sospetti abusi edilizi (quelli che sono stati etichettati dalla stampa come “grattacieli abusivi”).
Tutto ciò racconta bene come un certo modello di sviluppo urbano – che genericamente definiamo “neoliberista” – sia divenuto un assunto acriticamente accettato e promosso dalle forze politiche tanto di destra quanto di centro-sinistra. È il modello che Milano incarna in modo emblematico, fondato sull’intreccio tra diverse idee: che la crescita urbana, soprattutto nella forma dei grandi progetti di “rigenerazione” finanziati da capitali internazionali, sia sempre positiva; che sia necessario posizionarsi nell’arena competitiva globale a suon di grandi eventi, progetti urbani appariscenti e urban branding (ossia produzione di narrazioni, slogan e loghi, come lo sventurato “Milano non si ferma” dei tempi della pandemia); che attrarre turisti e classe creativa sia la risposta più praticabile alla crisi della base economica cittadina. Tuttavia, proprio a Milano è divenuto evidente che non solo questi assunti sono spesso falsi, ma che essi hanno un lato oscuro: quello di impatti sociali drammatici su fasce ampie di popolazione – ben più ampie di quanto si immagini, tant’è vero che a pagarne le conseguenze non sono solo i più poveri, ma anche porzioni crescenti di classe media che non riescono più a trovare un alloggio in città. La profonda problematicità del modello Milano, che ormai emerge con chiarezza, dovrebbe dunque essere un monito per tutte le città che vogliono imitarlo – tra l’altro, senza avere la forza economica e la capacità competitiva del capoluogo lombardo.
A.D.: In Piemonte si sta cercando di manomettere quel che rimane di una buona legge urbanistica, che risale al 1977 e che oggi pare essere diventata obsoleta per molti sia nel centro destra che nel centrosinistra. Il governo pubblico del territorio è diventato un fardello insopportabile?
F.C.: Il governo pubblico del territorio è un fardello solo a certe condizioni. In altri casi, al contrario, è una risorsa preziosissima per gli operatori economici, perché permette di avviare processi di valorizzazione del suolo che generano profitti stellari con bassissimi rischi d’impresa. Non a caso, per quanto siamo immersi da diversi decenni in un contesto di privatizzazioni e smantellamento di pezzi rilevanti di stato sociale, l’urbanistica rimane saldamente in mano ai decisori politici locali. Tutte le trasformazioni urbane, da quelle più minute a quelle più rilevanti, passano ancora attraverso le maglie del controllo pubblico (dei permessi di costruzione, delle convezioni urbanistiche, dei piani di dettaglio, dei piani regolatori generali, dei pareri delle commissioni comunali). Certo, il pubblico è sempre più dipendente dagli operatori privati per la realizzazione di trasformazioni urbane rilevanti, che non ha le risorse endogene per realizzare in autonomia. Ma ciò non toglie che il potere di regolazione rimane saldamente nelle sue mani. Credo quindi che il problema dell’urbanistica italiana non sia la mancanza di controllo pubblico, quanto il suo assoggettamento a logiche private, spesso lecite (ma politicamente ed eticamente stigmatizzabili) talvolta pure illecite. Da questo punto di vista, il caso milanese che ho menzionato prima è, ancora una volta, emblematico: le pratiche corruttive e le relazioni opache tra costruttori, professionisti, burocratici e assessori ipotizzate dalla magistratura non raccontano di un’assenza di potere di regolazione e controllo da parte del governo municipale; raccontano del suo asservimento a un preciso modello di sviluppo e a precisi valori.
A.D.: Cosa pensi del Disegno di Legge Delega, appena passato al Senato, che va a cambiare il ruolo delle Soprintendenze entro l’articolo 9 della nostra Costituzione?
F.C.: Il Disegno di legge delega passato al Senato è stato correttamente interpretato come un attacco al dettato costituzionale relativamente alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Può tuttavia essere letto anche alla luce di quanto ho detto in precedenza. Infatti, sulla carta non elimina il controllo pubblico della tutela del paesaggio e del patrimonio che, sebbene non sia più sottoposto in molti casi al parere vincolante delle Sopraintendenze (il loro giudizio diviene infatti obbligatorio ma non vincolante), potrebbe continuare a essere protetto dai comuni attraverso le proprie decisioni urbanistiche. Il problema è che tale disegno di legge accentra tale potere nelle mani di un solo livello di governo, quello locale. In questo modo fa sì non vi sia più alcun soggetto terzo che si possa mettere in mezzo alla partita che la politica locale gioca con i grandi (e piccoli) sviluppatori immobiliari.