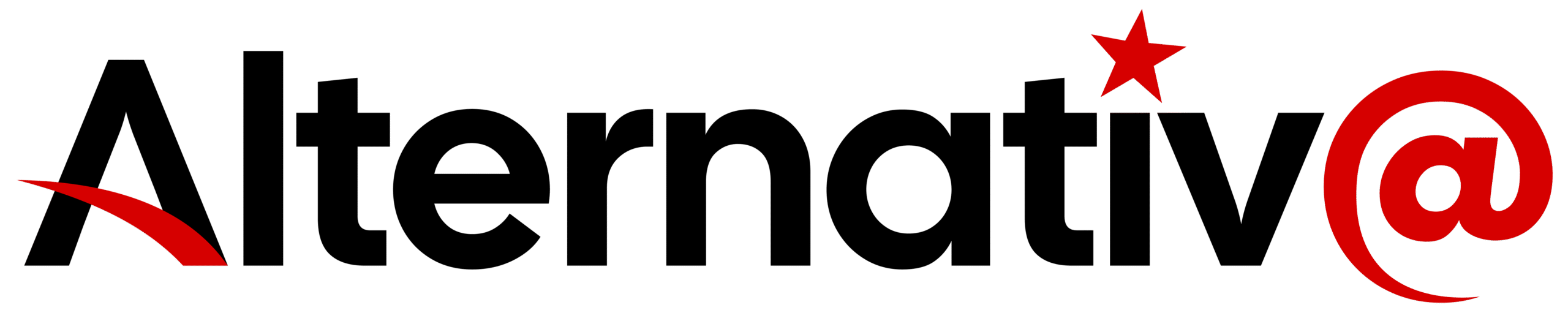Guido Ortona, già professore ordinario di Politica Economica presso l’Università del Piemonte Orientale (UPO)
Roberto Cabrino: Le manifestazioni a sostegno di Gaza e della Palestina hanno dimostrato una grande capacità di mobilitazione e hanno coinvolto settori della popolazione meno presenti nei tradizionali spazi politici. Come si può valorizzare questa energia oltre la spinta etico morale che l’ha sicuramente mossa oltre il senso diffuso di impotenza?
Guido Ortona:La mobilitazione per Gaza è stata enorme e sostanzialmente spontanea, nel senso che i gruppi organizzati che la hanno indetta hanno incontrato l’adesione di grandi quantità di persone che poco o nulla avevano a che fare con quei gruppi. Quelle persone, e i giovani in particolare, sono state indotte a partecipare da un lato dalla rilevanza etica di tale mobilitazione, e da un altro dalla intuizione che esisteva una realistica possibilità che la mobilitazione, data la sua ampiezza mondiale, potesse servire. Come infatti è servita, anche se siamo ancora lontani da una soluzione del conflitto, e molto lontani da una soluzione equa. Se le cose stanno così, allora chi vuole farsi carico della promozione della continuazione della lotta, quindi della trasformazione di un movimento di solidarietà internazionale in un movimento politico sui problemi nazionali, deve sapere proporre i due elementi citati: indicare un terreno di conflitto che sia eticamente giusto, e indicare obbiettivi che siano realistici, anche se inevitabilmente difficili. Ora, lottare per obbiettivi eticamente giusti e praticabili vuole dire inevitabilmente lottare contro qualcuno. Tutti i politici vogliono la pace; molti di essi, probabilmente una maggioranza, sono però favorevoli al riarmo dell’Europa. Abbiamo quindi una contraddizione. Se si vuole favorire una vasta mobilitazione, allora bisogna fare proposte chiare e conflittuali, ma questo produrrà una reazione da parte dei media e delle istituzioni assai più aspra che non nel caso della mobilitazione per Gaza. In sostanza, non si può saltare un passaggio difficile ma necessario, quello dell’indicazione di “parole d’ordine” appunto giuste e praticabili; ma anche che vadano al nocciolo dei problemi. “Giuste” in modo tale da propiziare una mobilitazione etica – per esempio il rifiuto del riarmo; “Praticabili” non nel senso che tutti siano d’accordo, ma nel senso che la loro realizzazione deve bensì essere ottenuta con la lotta, ma tale lotta può essere vincente – per esempio, un’imposta sulle ricchezze dei più ricchi; e “che vadano al nocciolo dei problemi” nel senso che aprano un conflitto volto a spezzare i vincoli che impediscono di attuare politiche di sinistra – per esempio la lotta contro il Patto di Stabilità Europeo. In altri termini, le “parole d’ordine” devono riguardare problemi importanti. Non si può ottenere una grande mobilitazione nazionale su problemi locali.
R.C.: Analizzando il fallimento storico nel far convivere positivamente movimenti, associazioni, sindacati e partiti, quali meccanismi concreti potrebbero essere messi in atto, per stabilire patti di cooperazione e interazione positiva? Come si può superare la reciproca diffidenza e valorizzare il ruolo di ciascun attore?
G.O.: Credo che si debba prendere atto di un fatto storico molto importante, e cioè la fine della classe operaia e quindi della identificazione degli interessi della classe operaia con quelli più generali dell’umanità. Gli operai esistono ancora, naturalmente, e sono tanti. Ma non esistono più come classe, cioè come un vasto insieme di persone con interessi comuni tali da far sì che la soluzione dei problemi di ciascuno, e il miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno, richieda la soluzione dei problemi di tutti. Fino a qualche decennio fa (mi riferisco all’Italia, e semplifico per chiarezza) per l’operaio della fabbrica X era chiaro che ottenere il Servizio Pubblico Nazionale o lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori era almeno altrettanto importante dell’ottenere dei miglioramenti locali, in quanto tali necessariamente piccoli; e questo richiedeva l’appoggio dei compagni delle fabbriche Y, Z… che la pensavano allo stesso modo. Oggi non è più così; la globalizzazione da una parte e la perdita di potere dello Stato dall’altra fanno sì che ogni fabbrica, al limite ogni singolo lavoratore, debba lottare per conto suo. Ma la perdita della centralità operaia (che in realtà è sempre stata meno universale di quanto si sperava “ai cancelli di Mirafiori”) ha avuto conseguenze deleterie anche sul piano dell’elaborazione politica: la politica della sinistra si basava sull’idea che gli operai, ottenendo vittorie riguardo ai propri interessi, avrebbero per ciò stesso realizzato un grande passo in avanti per l’intera società. Per qualche anno, mezzo secolo fa, questo è stato in buona parte vero; ma adesso questo non lo è più, proprio a causa della scomparsa della classe operaia nel senso visto più sopra. E allora? Allora bisognerebbe che la sinistra riuscisse a proporre obbiettivi unificanti per tutti i cittadini, che di nuovo facciano sì che ciascuno veda nella realizzazione di questi obbiettivi tramite una lotta comune la soluzione dei propri problemi. Oggi un obbiettivo di questo tipo potrebbe (e a mio avviso dovrebbe) essere il rilancio dello Stato sociale, il che implica naturalmente una seria redistribuzione delle risorse. Ho l’impressione che a sinistra questo cambiamento storico –la fine della centralità della classe operaia- non sia stato adeguatamente compreso.
R.C.: Riferendoci al tuo lavoro su un programma politico di sinistra e agli errori di struttura del passato, ritieni che l’incapacità di ricomposizione sia principalmente dovuto a divergenze programmatiche o a una carenza di cultura politica condivisa? Quali elementi culturali, oltre alle proposte economiche, dovrebbero essere al centro di un nuovo patto fondativo?
G.O.: Per rispondere a questa domanda farò un ragionamento schematico, che certamente è insufficiente per quanto riguarda i dettagli, ma mi auguro sia abbastanza giusto nella sostanza. Oggi chi milita a sinistra, e anche chi dice di essere di sinistra senza esserlo, ritiene, o dice di ritenere che “bisogna partire dai problemi reali della gente”. Ma cosa è un “problema reale”? Un problema reale è, per esempio, la chiusura dell’ospedale della città di X. Un altro è il ripristino della ferrovia per i pendolari nei sobborghi di Y. E così via. Questi sono problemi reali locali e relativamente piccoli. Poi ci sono i problemi reali locali ma grandi – il Ponte sullo Stretto, la TAV, e altro. La mobilitazione sia sui primi che sui secondi è giusta e importante. Ma sulla base di ciò che ho detto rispondendo alle domande precedenti, mi sento di affermare che dall’unificazione di queste lotte non può nascere un movimento nazionale paragonabile a quelli di cinquanta anni fa. Per due motivi. Il primo è che un movimento locale non è in grado di dire “dove trovare i soldi”, o meglio, ciascuno li chiederà per il proprio obbiettivo, ma ciò non è assolutamente equivalente all’indicazione di una seria politica redistributiva. Il secondo, e più importante, è che mancherebbe l’elemento fondamentale indicato più sopra, e cioè che ciascuno possa pensare che il raggiungimento dell’obbiettivo su cui ci si mobilita possa determinare un miglioramento per la propria condizione. Chi abita a Bolzano potrà essere solidale con chi lotta contro il ponte di Messina, potrà scender in piazza contro di esso, ma farà poco di più; e lo stesso vale, per esempio, per chi abita a Siracusa riguardo alla TAV. Ora, i politici realmente di sinistra che operano nelle istituzioni, vale a dire una parte consistente di Sinistra Italiana, una parte temo assai meno consistente dei 5S, e una parte minuscola del PD, non sono in grado di proporre politiche sui “grandi temi”. Sono troppo impegnati a occuparsi dei problemi locali. Introdurre i grandi temi nella necessaria contrattazione politica su di essi sarebbe “fuori tema”, e quindi inutile se non dannoso. Ma se occuparsi dei “grandi temi” è inutile, è inutile anche approfondirli, studiarli, ecc. Il risultato è paradossale: le priorità di quel poco che c’è di politica istituzionale di sinistra non sono determinate in base all’importanza dei problemi, ma in base a ciò che i politici impegnati nelle istituzioni conoscono meglio. Quando c’era ancora la classe operaia come tale si poteva presumere che le due cose coincidessero in larga misura; oggi non è più così. Se chiedete a un quadro intermedio, o anche apicale, cosa è il MES (che rischia di arrecare danni enormi al nostro paese), risponderà molto probabilmente che non sa cosa è, e non sapendolo penserà che non sia importante. Il che non toglie, anzi richiede, di parlare molto dei grandissimi problemi, come la crisi ambientale, a dimostrazione del fatto che si è portatori dei “valori della sinistra” e che, per esempio, la difesa del teatro Z nella città di W è il modo migliore di affermare quei valori. E’ un modo, certo, ma non il migliore. Ho cercato di approfondire questo discorso in un articolo su “Volere la Luna”, scaricabile dal loro sito, Che fare se chi dovrebbe farlo non lo fa? Il che ci porta all’ultima parte della domanda. Lenin disse una volta che uno dei compiti principali dei bolscevichi è imparare, un altro è imparare ancora di più, e un altro ancora è controllare ciò che si è imparato. La stessa cosa vale oggi per la “vera” sinistra. Bisogna capire quali sono i grandi problemi fondamentali, la cui mancata soluzione rende velleitaria ogni proposta seria di cambiamento. E fin qui è relativamente facile. A mio avviso lo sono i tre che ho indicato più sopra, e cioè il rifiuto del riarmo, il rifiuto del Patto europeo di Stabilità e una seria politica fiscale redistributiva. Ma poi viene il difficile: su questi temi bisogna elaborare proposte articolate e specifiche, e unitarie, il che richiede il superamento della mentalità “gruppettara” (il mio gruppo è quello giusto e il tuo no), così ridicolmente diffusa a sinistra. Difficile, ma non impossibile, su questi temi gli scienziati sociali di sinistra hanno parecchio da dire. E infine viene la parte difficilissima: trasferire queste proposte nella pratica politica dei politici di sinistra che lavorano nelle istituzioni. Difficilissimo, ma (forse) non impossibile.