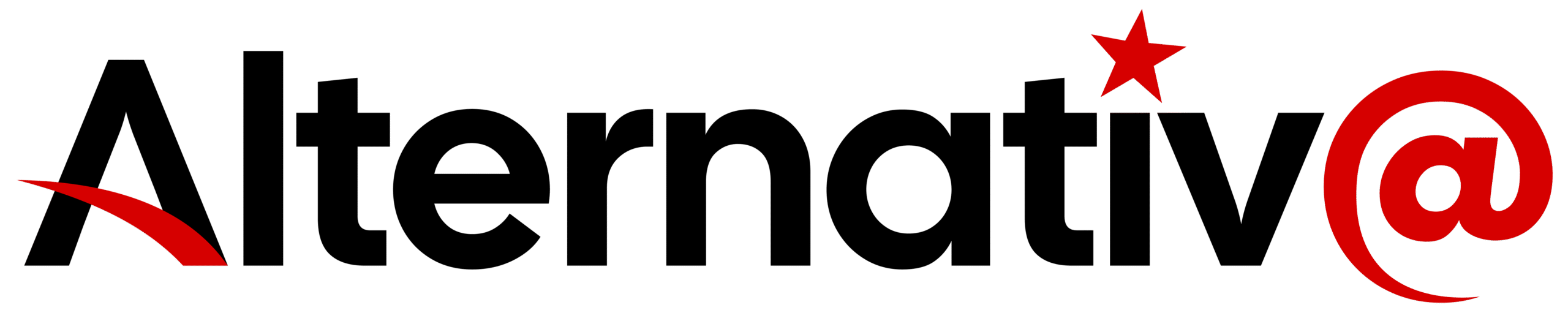Italo Di Sabato, coordinatore di Osservatorio Repressione
La ciclica “emergenza sicurezza” aleggia di nuovo sul dibattito politico italiano. Non è una novità: in passato l’invocazione tattica dell’ordine pubblico ha spesso spianato la strada alla destra, contribuendo a spostare il baricentro dell’opinione pubblica verso soluzioni muscolari e risposte immediate, purché appariscenti. Oggi il copione si ripete. La destra agita con forza il passepartout della retorica sicuritaria, che le ha consentito di far passare il ddl 1660 – poi trasformato nel decreto chiamato, non a caso, “sicurezza”.
Da allora Fratelli d’Italia e Lega competono a chi rilancia più forte: sfratti-lampo, caccia ai “maranza”, ritiri di cittadinanza, repressioni annunciate come spot elettorali. Il rischio, però, è che l’onda emergenzialista cominci a strisciare anche nel campo progressista, dove il riflesso dell’“ordine” come risposta immediata potrebbe tornare a manifestarsi.
Quando la sinistra rincorre la destra
Ciclicamente il dibattito sulla sicurezza torna a occupare la scena politica italiana, e quasi sempre lo fa nel modo sbagliato: come competizione simbolica tra partiti che cercano consenso facile più che soluzioni reali. È ciò che sta accadendo oggi nel Partito Democratico, dove riaffiora la tentazione di rincorrere la destra sul suo terreno, per non lasciarle l’esclusiva sul linguaggio dell’ordine pubblico.
Peccato che, mentre la discussione si riaccende, i dati dicano tutt’altro: la criminalità non aumenta, l’Italia resta tra i paesi più sicuri d’Europa. Eppure i numeri vengono manipolati, decontestualizzati, schiacciati dentro narrazioni emotive. La cronaca nera si trasforma in spettacolo continuo, e l’ultima variante è la “caccia ai ragazzini”, con episodi isolati elevati a emergenza nazionale.
Il vero nodo non è come garantire sicurezza, ma come sottrarre alla destra il monopolio simbolico sul tema. Così, mentre Meloni costruisce un immaginario epico fatto di minacce e soluzioni drastiche, nel Pd scatta il riflesso condizionato: mostrare rigore, durezza, severità. Una rincorsa destinata alla sconfitta, che evita la questione più centrale: la sicurezza dei diritti, sempre più fragile.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla precarizzazione del lavoro, alla frammentazione sociale, a una competizione esasperata. Le esistenze si sono fatte liquide, esposte alle pressioni del mercato globale e alla retorica della performance. A questo si aggiungono multiculturalità crescente, stili di vita plurali, percorsi individuali frammentati. In questa cornice, l’altro viene percepito come minaccia, non come potenziale alleato. È qui che prolifera il sicuritarismo: nelle pieghe di una società individualizzata, impaurita, priva di reti di senso collettivo e di protezione sociale.
L’emergenza come linguaggio politico trasversale
Va detto che la deriva emergenzialista non riguarda solo la destra o il Partito Democratico. Intorno al tema della “sicurezza”, nel tentativo di rivitalizzare il Movimento 5 Stelle e affrontare la crisi di consensi, Giuseppe Conte ripesca il vecchio armamentario giustizialista, mai del tutto dismesso. Neppure Alleanza Verdi e Sinistra ne è del tutto immune. Il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, esponente di Europa Verde, utilizza spesso i social per denunciare piccoli episodi di degrado urbano, trasformandoli in micro-allarmi continui. Una strategia comunicativa che finisce per alimentare la stessa narrativa binaria del “decoro contro il caos”.
Il meccanismo ricorda quello di Cicalone, che si muove nelle periferie romane e sulla metropolitana in una sorta di safari urbano alla ricerca di borseggiatori o “nemici del decoro”, talvolta affiancato da lottatori di palestra. Contenuti pensati per suscitare indignazione e percezione di assedio, più che per analizzare dinamiche sociali o proporre alternative.
Segno che la logica emergenzialista non è una posizione politica: è una grammatica emotiva, contagiosa e trasversale.
Quando la paura sostituisce la politica
In questo contesto, la sicurezza diventa un feticcio, una scorciatoia retorica che soppianta ogni discorso strutturale. I problemi concreti – precarietà, povertà, diritti deboli, mancanza di servizi – scompaiono, mentre domina la promessa di più polizia, più punizioni, più ordine.
Eppure una sinistra che voglia definirsi tale dovrebbe partire dal contrario: comprendere che la sicurezza non è un fatto individuale, né un’anomalia antropologica attribuita alle “classi pericolose”. È un prodotto delle trasformazioni economiche, delle disuguaglianze, della disgregazione sociale.
Ricominciare dalla sicurezza dei diritti
Per emanciparsi dalla subalternità culturale alla destra, il centrosinistra deve cambiare paradigma: parlare di sicurezza partendo dai diritti, non dalla punizione.
Sicurezza significa poter lavorare senza ricatti, abitare senza precarietà perpetua, muoversi nello spazio pubblico senza discriminazioni. Significa servizi che funzionano, comunità che si reggono sulla solidarietà, protezioni reali contro le vulnerabilità economiche.
In una società frammentata e impaurita, la risposta non è “più manette per tutti”, ma più giustizia sociale per tutti. Perché il crimine non paga, certo. Ma nemmeno la sua mitologia. E meno ancora paga la rassegnazione all’idea che l’unica sicurezza possibile sia quella raccontata dalla destra.