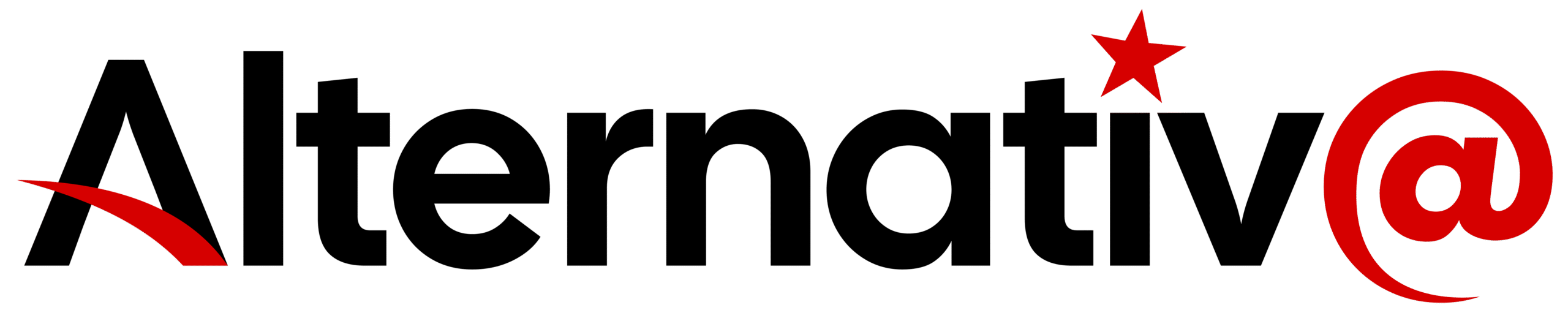1 – Preghiera per andare in paradiso con gli asini
Prenderò il mio bastone e sulla strada grande
Andrò, dicendo ai miei amici, gli asinelli:
Io sono Francis Jammes e vado in Paradiso
Ché non c’è inferno nel paese del buon Dio
(Francis Jammes)
Con i versi di questa poesia di un autore francese di una certa fama vissuto fra Otto e Novecento, letta in occasione del funerale di Goffredo Fofi, si apre il numero 122, settembre-ottobre 2025, della rivista «Gli asini», a lungo ispirata e guidata proprio da Fofi, da pochi mesi scomparso, al quale questo fascicolo è dedicato. Essa si occupa di educazione, di inchiesta pedagogica, di attivismo e riproduzione sociale, in maniera non accademica ma rigorosa; il taglio documentario e divulgativo non è affatto incline alla semplificazione e alla banalizzazione, la scrittura dei collaboratori mira all’essenziale senza rinunciare alla complessità. Non solletica, ma impegna il lettore, e questa mi sembra una buona notizia. Educazione significa impegno, e anche – soprattutto – cura di sé, cura degli altri, a cominciare dai più fragili. Significa anche fantasia, attenzione, originalità, anche nelle scelte grafiche; com-passione. Ecco, quasi per illustrare la linea della rivista, un passo di Dietrich Bonhoeffer, in queste pagine citato da Giancarlo Gaeta:
Resta un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato infine a guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi – in una parola: dei sofferenti. Se in questi tempi l’amarezza e l’astio non ci hanno corroso il cuore; se dunque vediamo con occhi nuovi le grandi e le piccole cose, la felicità e l’infelicità, la forza e la debolezza; e se la nostra capacità di vedere la grandezza, l’umanità, il diritto e la misericordia è diventata più chiara, più libera, più incorruttibile; se, anzi, la sofferenza personale è diventata una buona chiave, un principio fecondo nel rendere il mondo accessibile attraverso la riflessione e l’azione: tutto questo è una fortuna personale.
Gli Asini che danno il titolo alla rivista sono dunque i milioni di miti, inermi, i dimenticati della storia, le crisalidi che mai giungeranno a diventare farfalle ma sui quali si fonda la vita e il “progresso”.
2 – …gli oppressi
sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli
parlano nei telefoni…
(Franco Fortini)
Questo numero ha un tema, quello dei bambini e delle bambine, della loro esperienza fin dall’infanzia, e della loro accoglienza; e, coerentemente, la compresenza speculare di madri e padri. La qualità e la originalità degli interventi è veramente ammirevole. Cosicché con dolore elimino ogni altro resoconto, per selezionare due contributi, relativi a condizioni estreme, in pace e in guerra. Cominciamo dalla guerra, per concludere poi in maniera più dolce e aperta alla speranza di un mondo migliore. Non è il massacro di bambini a Gaza, che pure è argomento di questo numero; ma un diverso, quasi ignoto e non meno atroce, massacro.
L’altro lato dello schermo, milioni di bambini massacrati in Congo. L’articolo è una sintesi del lavoro di un giornalista e ricercatore francese, Fabien Lebrun, che all’argomento ha dedicato più di un libro. Si tratta dei bambini costretti, in Congo, a lavorare in dure condizioni di schiavitù, nelle miniere del coltan, minerale necessario alle nostre batterie, per i cellulari, e i computer ecc. Se i diretti massacratori sono, probabilmente da ascrivere alle bande locali, i committenti, gli oppressori, sono quelli che si scambiano mail e documenti dalle sedi finanziarie e dai consigli d’amministrazione delle grandi imprese: Apple, Dell, HP, Microsoft, Huawei, Vodafone e Sony sono qui elencate fra le altre, da rapporti di Amnesty International. Leggiamo uno fra i passi più impressionanti, tale da far impallidire le pagine sui piccoli minatori dello zolfo nell’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, apparsa nel 1877.
Per estrarre il cobalto, senza il quale gli schermi non funzionano, i bambini lavorano a mani e a piedi nudi, sotto il sole cocente o sotto la pioggia, trasportando sacchi da 20 a 40 kg. Guadagnano uno o due dollari al giorno, che spesso vengono loro sottratti dalla polizia. Altri bambini sono piegati in due per setacciare l’acqua in modo da estrarre l’oro che compone le schede madri e i circuiti stampati. E vengono pagati solo se trovano qualcosa. Contraggono malattie respiratorie e infezioni polmonari a causa dell’inalazione di polveri e droghe. Possono lavorare 72 ore senza sosta, sfruttati perché docili e piccoli, in grado di infilarsi in gallerie e tubi profondi fino a 60 metri che a volte crollano. Martirizzati, i loro corpi fragili sono mutilati, con arti amputati, teste fracassate, toraci sfondati, gambe schiacciate sotto pietre o incastrate nella roccia, a volte soffocati e sepolti sotto i minerali. Centinaia di bambini muoiono così durante le frane, scompaiono per sempre senza che nessuno lo sappia. Li chiamano i morti fantasma. Bambini senza contratto di lavoro né esistenza legale. Superflui, non lasciano traccia.
Risparmiamo al lettore altri passi atroci. Ma non dimentichiamo che questo lavoro produce i nostri luccicanti oggetti, resi necessari anzi indispensabili dalla moderna digitalizzazione. E riflettiamo sempre sul nesso fra civiltà e barbarie, fra guerra, profitto e sfruttamento. Ne ha scritto Walter Benjamin e, cent’anni prima di lui, anche il giovane Giacomo Leopardi (sì, proprio il poeta dell’Infinito).
Passiamo, per renderci l’aria meno irrespirabile, al secondo contributo, di Maurizio Braucci, dal titolo Il tempo dei padri. Si tratta anche questa volta di dar conto di un volume della antropologa statunitense Sarah Blaffer Hrdy (Il tempo dei padri. L’istinto maschile nella cura dei figli, per Bollati Boringhieri). La studiosa contraddice l’idea invalsa «di selezione sessuale per la specie umana basata sulle funzioni della madre accudente e del padre procacciatore di cibo». Si parte da esperienze sociali oggi sempre più diffuse, per le quali un numero crescente di padri affiancano le madri nell’accudimento dei bambini; un’idea che smentisce i luoghi comuni sul rapporto fra neonati e padri adulti. Una di queste ragioni, sostiene Hrdy, sta nel “potere trasformativo dei neonati” dovuto all’effetto sul cervello che il contatto costante coi piccoli produce. La neurobiologia e la paleontologia qui si saldano, e ci aiutano a leggere la storia sociale dei nostri giorni, i suoi positivi mutamenti. Da ritrovamenti archeologici, e in particolare dalla scoperta, nel 2000, di una grotta preistorica in Israele nel 2000, nella quale la disposizione delle ossa lasciava indovinare una piccola tribù, si comincia a verificare che la distribuzione del lavoro fra “produzione” e “riproduzione”, suddivisa fra maschi e femmine, non sia stata la verità, e certo non l’esclusività. Elementi affettivi dovuti all’influenza del contatto costante coi bamcini si intrecciano ad elementi sociali, a interconnessioni fra “lavoro” e cura che coinvolgono i padri oltre che le madri. Un dato che lascia ben sperare, proprio perché ancestrale e forse radicato nel nostro patrimonio evolutivo, e dunque capace di riproporsi.
Per i meno giovani: il fascicolo si apre ricordando Goffredo Fofi, e si chiude con un ricordo di Francesco Ciafaloni, anch’egli da poco scomparso: è stato un intellettuale, consulente editoriale di spicco, acuto e ironico, un sindacalista. Un compagno che merita di non essere dimenticato. (Per chi voglia saperne di più: https://www.ospiteingrato.unisi.it/per-francesco-ciafaloni/)