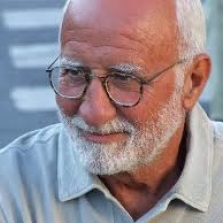Giovanni Mazzetti, economista
Abbiamo incontrato il professor Mazzetti, la voce più chiara, documentata e lucida in merito al tema pensionistico e a quello riguardante la riduzione strategica dell’orario di lavoro, nel momento in cui si susseguono le convulsioni governative intorno alle decisioni che dovrebbero riguardare milioni di pensionate e pensionati nel nostro Paese. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e ci proponiamo di continuare a lavorare su questi nodi, secondo le sue feconde indicazioni.
Alberto Deambrogio: Professor Mazzetti, nonostante le ricorrenti promesse di un superamento della legge Fornero, i recenti interventi del Governo continuano a muoversi in una direzione di penalizzazione dei pensionati e delle pensionate. Questa “eterna incompiuta” sembra confermare che la previdenza sia usata come un bancomat fiscale piuttosto che come un pilastro sociale. Come si può rompere questo cortocircuito politico che vede nel pensionato un peso economico anziché l’espressione di un diritto maturato e di un ciclo di vita che dovrebbe liberare spazio per le nuove generazioni?
Giovanni Mazzetti: Poiché la pretesa di superare la legge Fornero, da parte della Lega, era solo un tentativo di strumentalizzare ruffianamente il malcontento che aveva causato, ma non poggiava su una comprensione critica dei danni che quella legge faceva, non poteva produrre nulla di buono. Per questo oggi si cade nel ridicolo, di proposte che vengono ritirate prima ancora di essere discusse. Già era insensato imporre delle finestre, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, per andare effettivamente in pensione, ma introducendo altre finestre (semestrali!) per ricevere il pagamento della somma maturata rappresenta una vera e propria truffa. Così come sarebbe stata una truffa negare il riscatto degli anni di studio a chi ha già versato i contributi. Il corto circuito che ha fatto saltare il sistema pensionistico non può essere rotto fintanto che lo stato pretende di ragionare come un’assicurazione privata, sperimentando ogni spesa come un mero costo, invece che come la conferma di un diritto, com’è stato fino alla controriforma che abbandonava il retributivo imponendo il sistema contributivo per il calcolo della pensione.
A.D.: Lei ha spesso sostenuto che il dogma della non sostenibilità del sistema pensionistico sia un falso ideologico costruito per giustificare tagli alla spesa pubblica. Mentre gran parte della sinistra sembra aver interiorizzato i vincoli di bilancio europei, limitandosi a rivendicazioni difensive. Quali dovrebbero essere i cardini di un dibattito serio e contro-egemonico che riporti al centro la funzione civile della pensione e la necessità di finanziare il welfare non solo attraverso i contributi sul lavoro, ma tramite una tassazione più equa della ricchezza e dei guadagni di produttività.
G.M: Più che un falso ideologico direi che si tratta del trascinarsi di una cultura valida per il passato ma assolutamente contraddittoria rispetto alla situazione odierna. Bisogna tener presente, però, che se dalla controriforma Dini del 1995 ad oggi i conservatori sono riusciti a peggiorare ulteriormente il sistema è perché la maggior parte della popolazione e dei partiti dell’opposizione condividono i presupposti paradigmatici di quella cultura arcaica. Che cosa c’è di sbagliato nel senso comune odierno? Se le pensioni fino a quella controriforma erano agganciate alle retribuzioni e non ai contributi versati era per una razionale politica economica che si basava sugli sviluppi delle conoscenze successive alla Seconda Guerra Mondiale. Nel lontano passato il sistema previdenziale pubblico non si differenziava da qualsiasi assicurazione privata. La pensione era commisurata ai contributi versati, nel 1973, in piena coerenza con l’ascesa dello stato sociale keynesiano, si passò al sistema retributivo. Qual era il fondamento di questa scelta politica?Il contributo che ogni lavoratore dà alla società nel corso della sua vita lavorativa non è data dai soldi che accantona. E’ semmai l’aumento della sua capacità produttiva che ci dice quanto ha “dato”, cosa che si riflette solo in parte nei salari e nei contributi. I soldi che ha accantonato all’inizio della sua attività sono, in genere, misera cosa rispetto a questo contributo materiale. E se non si permette al pensionato di godere di questi frutti, il sistema si avvita su se stesso in un ristagno strutturale, come sta avvenendo da mezzo secolo, nel quale ci siamo drammaticamente impoveriti.
A.D.: Il suo pluridecennale lavoro sulla redistribuzione del lavoro appare oggi più urgente che mai, in un’epoca di accelerazione tecnologica e automazione. Eppure, il discorso sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario viene spesso relegato a utopia o a esperimento aziendale isolato. In che modo questa proposta può diventare scelta strategica di sistema, capace di saldare la questione previdenziale con la necessità di rispondere alla crisi della società salariale?
G.M.: La condizione essenziale per intraprendere una lotta, con qualche prospettiva di riuscire a reggerla, è quella di accogliere l’insegnamento di Marx secondo il quale lo stesso sviluppo capitalistico avrebbe via via reso più difficile riprodurre il lavoro salariato. Poiché questo rappresenta una delle condizioni per la riproduzione dei rapporti capitalistici è inevitabile il sopravvenire di una crisi. Per comprendere questo passaggio evolutivo – che abbiamo compiuto nel dopoguerra – bisogna però saper ricostruire la storia dell’ultimo secolo, quando appunto il fenomeno prospettato da Marx si è concretamente verificato ed abbiamo elaborato una strategia vincente con lo Stato Sociale keynesiano. Fintanto che questo non avviene il lavoro si trasforma in un rapporto sostanzialmente servile, e i lavoratori chiederanno soltanto che il loro lavoro salariato venga riprodotto in condizioni sempre più miserevoli, invece di imparare a godere del tempo libero, oltre ad imparare a produrre sulla base di rapporti superiori rispetto a quello del denaro.