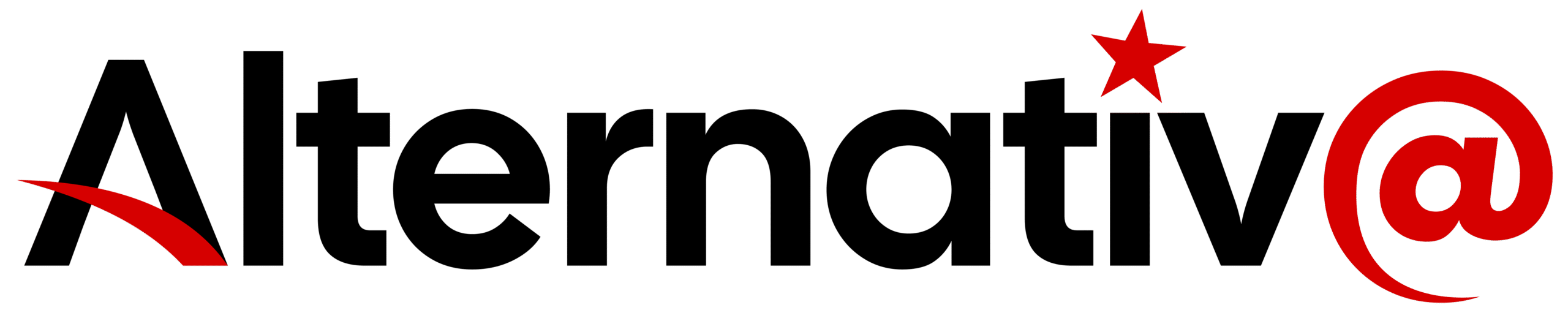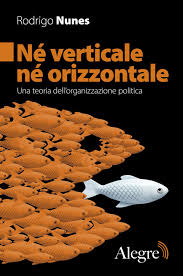RODRIGO NUNES è professore di teoria politica, Università di Essex (Regno Unito) e Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (Brasile)
Alberto Deambrogio: Nel tuo libro parli di una melanconia di sinistra da superare. Per farlo rovesci un canone stabilito, parti cioè non da una nuova proposta organizzativa, bensì dalla chiarificazione dell’esistente. Puoi spiegarci perché è utile una operazione di questo tipo?
Rodrigo Nunes: La grammatica tradizionale della riflessione sull’organizzazione suppone qualche presupposto che non viene mai esplicitato: che l’organizzazione è qualcosa che esiste soltanto all’interno delle singole organizzazioni; che c’è una forma organizzativa ideale che tutte le organizzazione dovrebbero seguire, addirittura forse che c`è una sola organizzazione che deve essere l’ombrello per tutto il resto (ecco il partito); che la cosiddetta “questione dell’organizzazione” sarebbe allora la ricerca di questa forma o anche di questa organizzazione; e che, una volta trovate, loro ci permetterebbero finalmente di vincere. C’è forse un buon motivo per non declinarle esplicitamente, perché suona veramente fantasioso se lo facciamo! Invece, mi sembra necessario partire dal dire che c’è dell’organizzazione dappertutto, e che essa può prendere forme, tipi, gradi e scale spaziotemporali diversi; che allora ogni organizzazione è sempre circondata da un’ambiente che è ormai organizzato, dove cioè ci sono rapporti organizzativi formali o informali tra delle organizzazioni, tra persone, tra persone ed organizzazioni ecc.; che questa ecologia organizzativa è in questo senso sempre plurale; e che perciò non si tratta di cercare una forma ideale, per almeno tre ragioni. Primo, perché differenti gradi, forme, tipi e scale esistono per differenti fini, e questa pluralità può infatti essere un vantaggio; secondo, perché la forma ideale non c’è, nel senso che sono sempre i rapporti di forza interni ed esterni che determinano cosa un’organizzazione effettivamente è o può essere ad ogni dato momento; e terzo, perché ciò che può vincere non è mai una organizzazione isolata, è anzi un’ecologia che può essere più centralizzata o più dispersa, ma comprenderà sempre una certa eterogeneità.
A.D.: Nel parlare del partito nel tuo ragionamento eviti di inoltrarti nel dibattito, abbastanza in voga anche in Italia sino a non molto tempo fa, del superamento di quella forma e invece sostieni che è più utile parlare di forze che si confrontano al suo interno. Vuoi descriverci questo approccio?
R.N.: Si, la scommessa sulla forma partito è l’esempio più estremo della credenza alla forma ideale, quella sulla sua abolizione non è altro che la stessa credenza con segnale invertito: quello che ci ha impedito sempre di vincere è stato il partito, allora se lo eliminiamo saremo infine vittoriosi. I partiti esistono, è quello basta perché siano elementi di un’ecologia; le domande che contano non sono, pertanto, quelle relative alla loro esistenza, ma piuttosto: quale funzione svolgono? Le svolgono a profitto dell’ecologia nel suo complesso, oppure secondo i propri interessi? Quali sono i rapporti di forza al loro interno e, ancora più importante, con il resto dell’ecologia? Quanto sono rettivi nei confronti delle altre forze, quanto sono aperti a lasciarsi influenzare dall’ecologia? C’è una funzione politica per cui il partito è senza dubbio la forma più adeguata, vale a dire la partecipazione alla politica rappresentativa; e finché ci sarà lo Stato, questa sembra una dimensione che non possiamo abbandonare del tutto –– se non per fare il meglio, almeno per evitare il peggio. Ma anche con il migliore partito, la relazione ideale da stabilire è sempre basata su una certa distanza, una certa tensione, avendo non troppa dipendenza, non eccessiva centralizzazione intorno a lui; perché è proprio questo che ci offre la più grande possibilità di esercitare un certo controllo su di esso.
A.D.: Tu insisti molto sulla necessità di lavorare a una ricomposizione politica a partire dalla riproduzione sociale attraverso temi che costituiscono identità trasversali. Vuoi dirci cosa pensi di un possibile rafforzamento reciproco tra questi temi e la spinta che ha portato in piazza milioni di persone nel mondo contro il genocidio palestinese? È possibile cioè una connessione tra una critica alla barbarie, alla guerra e le su ricadute sulla riproduzione sociale quotidiana?
R.N.: La prima cosa a dire è che la questione palestinese è stata in Italia un punto di ricomposizione del tutto diverso da quelli che immaginavo quando ho scritto il libro –– ciò ci prova che, benché si debba sempre fare uno sforzo di lettura della realtà per trovarne i punti critici, non si può proprio mai indovinare da dove verrà la spinta che fa andare avanti le cose. Nel libro propongo che la politica si debba fare sempre con un senso di direzionalità: non solo un desiderio sconnesso di un altro mondo aldilà della nostra vita e pratica presente, ma una scommessa strategica concreta su dove e con quali forze cominciare, quali passi fare, dove fare leva, come costruire e impiegare la potenza dell’agire collettivo che ci possa ampliare lo spazio di possibilità e portarci più vicino a quell’orizzonte che immaginiamo. Anche se c’è tantissimo che possiamo scoprire solo mentre percorriamo la strada, se non abbiamo una mappa almeno provvisoria del cammino, non abbiamo nemmeno i criteri per valutare quello che facciamo e che ci succede. E poiché questi sono sempre affari di potenza collettiva, ha sempre più senso partire da problemi che sono già riconosciuti e condivisi da un grande numero di persone. Ciò di solito vuol dire i colli di bottiglia della riproduzione sociale: questioni come l’abitazione, il debito, i servizi pubblici. Sono pure punti che hanno una rilevanza strutturale – se si muovono, muovono altre cose con sé – dunque la strategia è essenzialmente il lavoro per inventarsi i mezzi organizzativi e le tappe concrete che ci permettono di produrre una forza capace di muoverli. Se la Palestina ha potuto fungere da punto di partenza di un processo di ricomposizione è perché il genocidio ci porta al limite del nostro senso di giustizia e compassione; ma credo che, per poter realizzare il suo potenziale, questo processo dovrà allora trovare insediamento nella vita quotidiana, e la sfida sarà stabilire le relazioni tra quello che succede a Gaza e quello che succede qui. Questo forse si può fare, per esempio, segnalando come l’attuale svolta europea verso una nuova economia di guerra vuol dire passare da un parassitismo della finanza sui bilanci statali a un parassitismo su questi anche dell’industria militare, in un momento in cui la gente è sempre meno protetta e dovremmo invece parlare di come investire nella transizione ecologica.
Rodrigo Nunes è in Italia in questi giorni per presentare il suo libro “Né verticale, né orizzontale. Una teoria dell’organizzazione politica” (Alegre). Qui si possono trovare i prossimi appuntamenti: https://edizionialegre.it/notizie/ne-orizzontale-ne-verticale-in-tour/