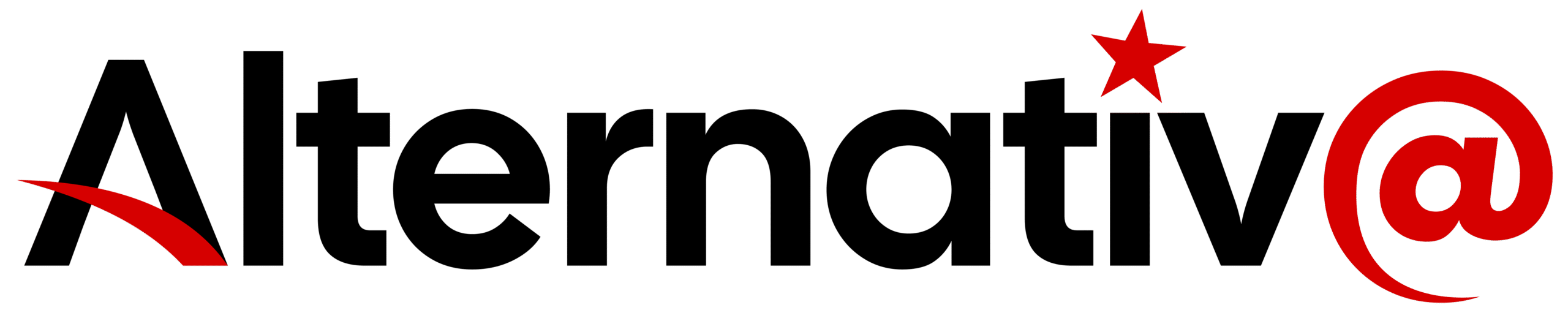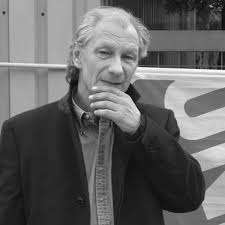Alberto Deambrogio: dopo alcuni mesi di sperimentazione di politica trumpiana dei dazi è possibile fare un primo bilancio. Tu stesso avevi sostenuto che c’era del metodo in ciò che molti osservatori liquidavano velocemente come irrazionale. Cosa ha portato a casa il Presidente USA? E l’Europa come si è mossa secondo te di fronte a questo atteggiamento?
Christian Marazzi: Non è semplice fare un bilancio dopo i pochi mesi trascorsi dal “liberation day” del 2 aprile. Continuo a credere che dietro alla politica dei dazi, per quanto erratica e soggetta a capovolte improvvise, ci sia del metodo. Di sicuro l’obiettivo resta quello di costringere il resto del mondo a “partecipare” al programma di reindustrializzazione degli Stati Uniti e a ridurre il disavanzo federale con le tasse sull’importazione di beni e servizi. Per il momento, però, gli effetti interni agli US, come il forte rincaro dei beni importati, non si sono dispiegati come previsto. Ci si aspetta però una ripresa sensibile dell’inflazione verso fine anno. Il mercato dei Treasury Bonds, che pure ha conosciuto qualche sbalzo importante, resta ancora il più sicuro per gli investitori globali. Lo stesso dollaro, che pure negli ultimi dieci anni ha perso peso come valuta di riserva detenuta dalle banche centrali, non sembra minacciato da nessun’altra valuta (anche se nell’ultimo anno il dollaro è stato l’unica moneta che ha conosciuto una diminuzione netta della domanda da parte delle banche centrali). Semmai, è la sostenibilità fiscale che rappresenta un problema, con un deficit federale destinato a crescere dal 100% del Pil nel 2025 al 156% nel 2055. In una situazione in cui vi è un afflusso fenomenale di capitali sui mercati statunitensi per cavalcare l’euforia dell’Intelligenza artificiale, gli investitori cercano di compensare eventuali perdite dovute a una sempre più probabile esplosione della bolla AI con investimenti in oro e altri beni rifugio (che ha, tra l’altro, effetti svalutativi sul dollaro).
Il punto, però, è un altro: ci si sta rendendo conto che la strategia dei dazi non è efficace dal punto di vista degli US perché l’accesso al mercato americano non è così vitale come Trump si immagina! Gli Stati Uniti importano solo il 13% delle importazioni globali, molto al di sotto della quota del 25% del Pil globale. La politica dei dazi funziona piuttosto per costringere i paesi alleati a piegarsi alle strategie geopolitiche e militari di sicurezza, ma non incide granché sulla ridefinizione economico-industriale degli Stati Uniti. Insomma, i dazi sono l’arma più debole dell’arsenale economico americano. Il che significa, probabilmente, che se l’ondata di finanziarizzazione dovesse arrestarsi a causa della bolla AI, la crisi economica interna avrebbe effetti devastanti per il popolo americano.
A.D.: Non molti ne stanno parlando, almeno a livello di discussione di massa, ma i debiti nazionali tornano a essere un elemento critico. Non mi paiono alle viste operazioni di quantitative easing e allora ti chiedo: se ci dovesse essere una involuzione chi pagherebbe? E’ pronto un assalto a quel che rimane del bersaglio grosso del welfare state?
C.M.: Sì, decisamente. I debiti nazionali stanno aumentando come conseguenza delle politiche neoliberali degli ultimi due decenni, in particolare le misure di sgravi fiscali che hanno accompagnato le politiche di quantitative easing e che hanno contribuito a rafforzare la finanziarizzazione delle economie avanzate, senza davvero rispondere alle dinamiche sociali, demografiche e sanitarie che hanno attraversato le nostre società in questi ultimi anni (e si pensi solo alla pandemia). Di fronte all’aumento dei bisogni economici e finanziari interni ai singoli Stati, l’aggressività del ceto politico liberista è proporzionale al timore di dover aumentare la pressione fiscale sui ricchi per contenere i disavanzi fiscali. Sul fronte fiscale la rigidità politica è totale, pronta a rovesciarsi in repressione politica. È quindi il welfare state il bersaglio privilegiato di questo ceto liberista.
A.D.: Con la crisi del dollaro come moneta di riferimento internazionale è partita la corsa all’oro da una parte e, dall’altra, il proporsi delle cosiddette stablecoin come garanzia della tenuta del sistema americano. Puoi dirci cosa pensi di tutto questo e in particolare delle possibili turbolenze, delle vere e proprie nuove crisi, nel settore finanziario e bancario?
C.M.: Del dollaro ho già detto prima, in particolare la sua svalutazione degli ultimi tempi va interpretata, almeno per il momento, alla luce della paradossale congiuntura che si è venuta a creare, con un forte afflusso di capitali sui mercati borsistici trainati dalla speculazione “irrazionale” sui titoli dell’AI, da una parte, e dal timore dell’incapacità del governo statunitense di gestire la crisi di sostenibilità fiscale, dall’altra. Da una parte si investe in attivi americani, dall’altra ci si protegge (hedge) contro il rischio di crisi indotta da un (possibile) aumento dei tassi di interesse per far fronte ai bisogni di finanziamento del debito pubblico. Una situazione schizofrenica, fra l’altro, che si riverbera all’interno della Federal Reserve, dove si cerca di trovare un compromesso tra politiche anti-inflattive (aumento dei tassi di interesse) e necessità di sostenere la crescita economica (diminuzione degli stessi tassi di interesse). Le stablecoin, le cripto valute ancorate/parificate al dollaro, rientrano perfettamente in questo scenario. Per mantenere la parità col dollaro, le stablecoins devono proteggersi con collaterali solidi, in particolare con l’acquisto di Treasury Bond, il che permette al Tesoro americano di avere un acquirente privato importante (e in crescita) di debito pubblico. Se poi si considera il fatto che molte imprese americane acquistano stablecoin e altre cripto valute come attivi a bilancio per attirare investitori (che considerano questo tipo di attivo a bilancio come garanzia di aumento dei profitti delle imprese in cui investono), ci si rende conto di quanto i destini della finanziarizzazione e della cosiddetta economia reale siano intrecciati, addirittura sovrapposti. Un crollo dei mercati finanziari trascinerebbe con sé il crollo dell’economia reale e pure del debito federale, una tempesta perfetta che, come accadde con la crisi dei subprime del 2008, avrebbe effetti immediati sua scala mondiale.