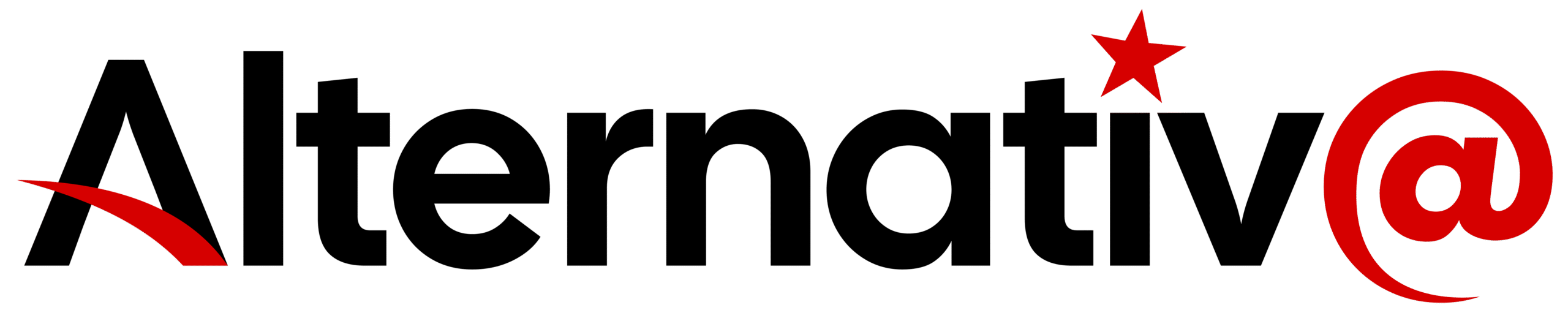Alla fermata della metro “piazza XVIII dicembre” scendono moltissimi giovani. Staranno andando al corteo? La risposta è immediata: appena fuori dalla stazione, intonano cori e srotolano striscioni. E il punto di partenza del corteo, la piazza del Comune, sarà già affollata, nonostante le informazioni contraddittorie sull’orario di ritrovo (9, 9.30, 10)? Non è facile preparare uno sciopero generale in 36 ore, soprattutto in assenza di partiti e movimenti di massa. Eppure già ci si muove a fatica, in quella che è stata ribattezzata piazza Gaza. Incontro persone amiche, altre che non mi aspettavo (tante coppie giovani, spesso con bambini), eppure lì, in quel momento, ci riconosciamo, perché parliamo lo stesso linguaggio. Quello dell’orrore per la sofferenza indicibile (e che pure va detta) del popolo palestinese; dello sdegno per la complicità dei governi (quelli occidentali come quelli arabi) nel genocidio e il loro doppio standard (Russia fuori dal consorzio civile, Israele partner d’affari e di competizioni sportive). E della consapevolezza che non dai governi né dall’ONU (da quegli stessi governi ignorata o addirittura criminalizzata) potrà venire una pace che non sia la continuazione della guerra per la spartizione del mercato globale.
In corso Vittorio, all’altezza di corso Ferrucci, il corteo (immenso) si divide; proseguo con quello che si dirige verso corso Francia, senza neanche sapere che è lo “spezzone sociale” diretto alla Leonardo. È che si sta bene, lì in mezzo: tolti gli “over” come me, sono quasi tutti giovanissimi. Diverse persone si affacciano a balconi e finestre per osservare chi manifesta; solo un uomo ci mostra il dito medio, per poi scappare in casa (poveretto), molti ci salutano e applaudono, ricambiati con entusiasmo, qualcuno intona con noi Bella ciao. Di questo ovviamente non vi è traccia sui media, troppo presi dalla routinaria stigmatizzazione delle “frange violente”, mentre insinuano il timore di una “radicalizzazione”, preludio del ritorno alla violenza politica degli anni Settanta. Ma non potrà ricattare queste ragazze e questi ragazzi di 15-20 anni con lo spettro del “terrorismo” rosso chi li ha ammutoliti con il suo disprezzo della vita umana: in Palestina, nel Mediterraneo, sui valichi di frontiera, ma anche nei cantieri dove lavoratori migranti vengono spremuti fino a rischiare la propria incolumità e la vita e, in caso di “incidente”, scaricati come spazzatura davanti a un ospedale. A chi ha vissuto, o studiato, il lungo ’68 italiano spetta il compito di ricordare, non solo ai più giovani, che cosa è stato il terrore di quegli anni – di Stato, fascista e poliziesco – oggi che le “democrazie liberali”, e la stessa Unione Europea, sono sempre più indistinguibili dai regimi autoritari e la ferocia è diventata la modalità scelta dal capitalismo per disciplinare le classi subalterne.
Della parola “violenza” dobbiamo riappropriarci, per scalzare il discorso che inesorabilmente la riduce all’atto di uno specifico individuo o gruppo (sempre appartenente a classi e popoli subalterni) in uno spaziotempo definito: ossia un evento che interromperebbe un ordine – quello capitalista – altrimenti lineare e pacifico. È questa violenza, che non esita ad annientare l’ambiente così come gli esseri viventi, che dobbiamo portare in primo piano; una violenza strutturale, perché insita nel funzionamento delle società in cui viviamo, dunque inestinguibile all’interno dell’attuale (dis)ordine globale.
Nel linguaggio comune che, pur tra differenze generazionali, culturali e politiche, abbiamo parlato il 3 ottobre (in una mobilitazione senza precedenti almeno da mezzo secolo a questa parte, lì a ricordarci come sia possibile bloccare un intero paese, facendo un rumore che non può essere ignorato), serpeggiava l’idea che, a breve, potremmo a nostra volta – noi, i privilegiati occidentali – diventare sacrificabili, se non arrestiamo la spinta sempre più isterica alla guerra contro Putin. L’epidemia di droni e sconfinamenti russi mira ad arruolarci non più solo simbolicamente, ma militarmente, nello scontro con l’arcinemico della civiltà (occidentale) – con cui peraltro le classi dirigenti europee e nordamericane hanno fatto affari ben oltre l’annessione della Crimea.
Se per la Palestina si prefigura la pace dei cimiteri (con Israele che continuerà a umiliarne il popolo e USA e Blair come garanti), sull’Europa, e gran parte del mondo, incombe la spada di Damocle di una guerra dall’esito potenzialmente senza ritorno.
Su questo il movimento nato in queste ultime settimane, grazie all’iniziativa dei sindacati di base che hanno capitalizzato un malessere covato da tempo, deve continuare a fare rumore, ciascuno con la sua storia e i suoi mezzi, ma costruendo un linguaggio condiviso, che reclami il diritto a un futuro degno di essere vissuto.