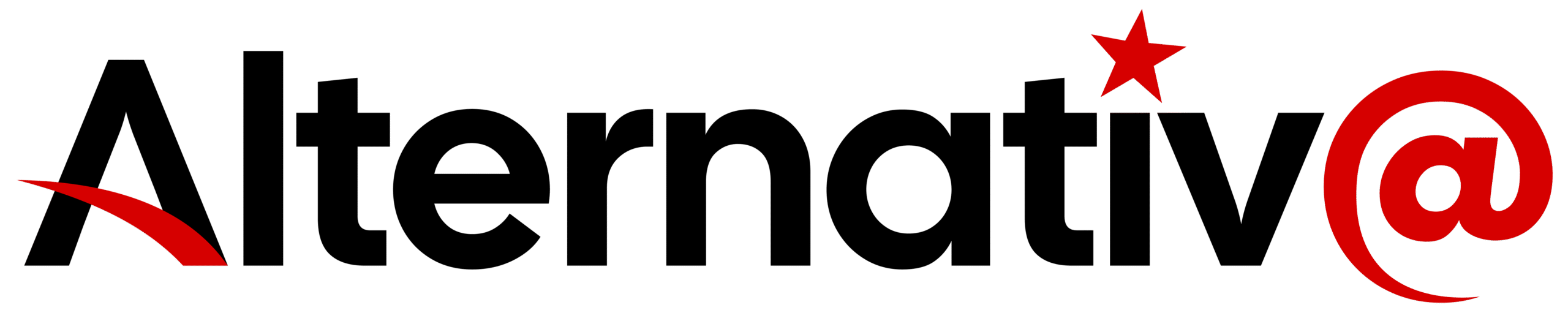In base alla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il ricovero di una persona presso una RSA accreditata e convenzionata con il Servizio sanitario pubblico comporta in linea generale una spesa a carico del paziente pari al 50% della tariffa giornaliera, essendo l’altro 50% a carico del Fondo sanitario (art. 30, comma 2, DPCM 12 gennaio 2017).
In una Regione come la Lombardia i costi di ricovero delle RSA sono particolarmente alti e differenziati sul territorio, perché a partire dal 2003 vi sono state una serie di delibere di giunta, che hanno fissato una “quota sanitaria” standard per tutti i posti contrattualizzati, suddivisa per tipologie di malati a seconda della gravità, lasciando campo libero sulla rimanente quota alberghiera agli enti gestori delle RSA. Tutto ciò secondo una logica contrattualistica di mercato, e non di programmazione pubblica dell’offerta sanitaria nel rispetto dei bisogni di salute della popolazione e del carattere universalistico ed egualitario cui è ispirata la riforma del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
Per ovviare in parte a questo problema, la normativa sui LEA prevede che i Comuni devono intervenire per contribuire al pagamento delle rette a sostegno dei pazienti economicamente bisognosi. Lo strumento di valutazione è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetto ISEE), disciplinato dal DPCM 159 del 2013, la cui finalità è quella di fornire agli enti pubblici un sistema di calcolo delle possibilità economiche delle persone (e dei nuclei familiari di riferimento), sulla base di determinati requisiti reddituali e patrimoniali, al fine di consentire agli utenti di accedere ai servizi sociali, e socio sanitari, pagando costi proporzionati alle loro effettive e certificate possibilità, ovvero ricevendo contributi monetari pubblici proporzionati per sostenere adeguatamente le rette delle strutture residenziali di ricovero; pena, altrimenti, la mancata fruizione dei servizi stessi ed il pregiudizio ai diritti fondamentali della persona.
Purtroppo però, sovente, i regolamenti comunali non sono rispettosi di questi principi normativi (per analizzare l’argomento occorre un approfondimento a parte), sicché accade spesso che, per sostenere rette di ricovero particolarmente alte, pur in RSA accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario pubblico, le persone sono costrette a impoverirsi, in spregio al principio dell’art. 32 della Costituzione, secondo il quale “La Repubblica… garantisce cure gratuite agli indigenti”. Secondo la Corte costituzionale (sentenze 185/1998 e n. 309/1999), la norma va interpretata anche nel senso che è compito del servizio sanitario pubblico prevenire il fenomeno dell’indigenza sanitaria, ossia l’impoverimento delle persone causato dal pagamento delle spese necessarie per la cura delle malattie, o la rinuncia alle cure adeguate per la mancanza di mezzi economici.
La motivazione spesso richiamata dagli Enti preposti al governo dei servizi sanitari e sociosanitari è la carenza/insufficienza di risorse. La vera questione non è, tuttavia, la limitatezza delle risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, innegabile e scontata, quanto piuttosto la decisione amministrativa sull’allocazione delle stesse, che dev’essere sempre rispettosa del perimetro costituzionale. In quest’ottica, occorre pertanto distinguere tra spese costituzionalmente necessarie (ad esempio quelle a supporto del servizio sanitario pubblico, comprese quelle previste per le persone malate croniche non autosufficienti, che non devono essere oggetto di tagli a pregiudizio dei diritti), spese costituzionalmente facoltative (sulle quali il parlamento nella legge di bilancio, e nei loro ambiti di competenza, Regioni e Comuni possono legittimamente operare tagli o scelte di discrezionalità politica) e spese costituzionalmente vietate (visto che l’Italia ripudia la guerra….).
Questo punto di vista è stato assunto in modo chiaro dalla Corte costituzionale, che, a far tempo dalla sentenza 275 del 2016, dopo la famigerata revisione costituzionale del 2012 approvata dalla stragrande maggioranza parlamentare a sostegno del governo Monti, sull’obbligo del pareggio di bilancio, ha stabilito che, pur in un contesto di risorse scarse, ed anche per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate da vincoli dell’Unione Europea, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il fondamentale diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione, che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione.
Date queste premesse occorre considerare che il ricovero di pazienti in condizioni di non autosufficienza, perché affetti da gravi patologie invalidanti, presso strutture residenziali protette di lungo degenza (quali sono le RSA), diventa sovente una soluzione obbligata (e non una libera scelta della persona o del suo care giver o del suo amministratore di sostegno). Infatti, allo stato organizzativo attuale del servizio sanitario, malati in queste condizioni non sono ricoverabili presso presidi ospedalieri (se non in casi di emergenze legati a fasi patologiche acute), poiché gli ospedali non hanno posti letto che possano garantire periodi di assistenza estremamente lunghi. Tanto meno in certe situazioni queste persone possono essere assistite adeguatamente mediante le cure domiciliari, poiché l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ad oggi prevista nei LEA non prevede figure professionali sanitarie, con le caratteristiche necessarie alle condizioni cliniche e funzionali di malati particolarmente gravi, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, presenti h 24 x 7 giorni.
A proposito dell’assistenza domiciliare una importante norma di riferimento sui LEA è l’articolo 22, comma 4, del DPCM 12 gennaio 2017, là dove è previsto che “le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi”. A ben vedere un’applicazione corretta di questa norma legata ai bisogni sanitari effettivi di un paziente, certificati da apposita Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) consentirebbe a molte persone colpite da malattie croniche invalidanti e ai loro familiari la possibilità di usufruire di durevoli e adeguate cure domiciliari, senza reiterare i ricoveri in ospedali e senza essere costrette a ricorrere, quale unica alternativa, al ricovero in RSA.
Fatta questa panoramica generale, è lecito domandarsi quanto segue: in quali casi le persone ricoverate in RSA hanno diritto di ricevere prestazioni a totale carico del servizio sanitario pubblico, in deroga al principio generale ricordato all’inizio di questa riflessione, relativo all’obbligo di pagare una retta, a copertura della quota cosiddetta alberghiera non coperta dalla quota sanitaria a carico del servizio sanitario? Consideriamo che tale obbligo pecuniario viene peraltro di fatto assunto nella prassi anche in via negoziale attraverso la sottoscrizione, da parte del paziente o del suo Amministratore di sostegno e di persone garanti, di apposito contratto di ingresso con l’Ente gestore (condizione senza la quale il ricovero in RSA peraltro non viene concesso).
Per rispondere al quesito è bene partire dal principio generale posto dall’articolo 2 dalla Legge 833 del 1978, che affida al Servizio sanitario pubblico, tra gli altri, anche il compito di garantire, senza i se e i ma dei tagli alla spesa sanitaria, “la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata”.
In questo contesto occorre interpretare ed applicare il LEA previsto dall’articolo 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001, che individua la categoria delle prestazioni ad “elevata integrazione sanitaria”, con le seguenti peculiarità:
a) presentano una “particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”;
b) sono rivolte anche a persone con “disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”;
c) sono prestazioni “attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza”;
d) “sono erogate dalle aziende sanitarie” (tramite gli enti gestori pubblici o privati accreditati e convenzionati col sistema pubblico)
e) “sono a carico del fondo sanitario” (senza alcuna compartecipazione da parte del paziente);
f) “possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali”; quindi anche in RSA
g) “sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza”.
Ciò detto il principio dovrebbe essere applicato nei confronti di quei pazienti ricoverati in RSA che hanno bisogni di cure sanitarie particolarmente rilevanti. Tuttavia nella realtà ciò non avviene quasi mai se non intraprendendo apposita causa giudiziale, come confermato da un articolo pubblicato su “Il fatto quotidiano” il 7 aprile 2025.
In pratica questo LEA non viene attivato di default dalle Aziende sanitarie. In base alla mia esperienza professionale posso confermare che le Agenzie Territoriali della Salute (che in Lombardia hanno sostituito le ASL) non riconoscono questo diritto nemmeno in via preventiva e stragiudiziale, anche quando, su apposita istanza scritta dell’avvocato di fiducia dell’amministratore di sostegno della persona interessata, esse vengono sollecitate a valutare la peculiarità del caso concreto, tramite apposita UVM, ai sensi dell’articolo 21 del DPCM 12 gennaio 2017.
L’articolo di stampa in commento espone i seguenti numeri significativi «tra il 2018 e il 2024 sono arrivati in Cassazione 16 ricorsi dalla Lombardia ai quali, dopo tre gradi di giudizio, è stato riconosciuto il 100% del costo della degenza a carico della Sanità». Sedici casi in sette anni! Sui tempi dei processi, non mi soffermo, ma chiaramente si tratta di vicende che si riferiscono ad anni addietro rispetto alla sentenza definitiva, molto spesso a paziente deceduto da tempo.
Occorre altresì considerare che per diversi anni la giurisprudenza è stata ondivaga nelle sue pronunce in materia. Tuttavia, a far tempo dal 2023, con specifico riguardo ad alcuni casi di persone malate di Alzheimer, che presentavano particolari bisogni di assistenza sanitaria, si è consolidato il principio presso la Corte di Cassazione, secondo cui le prestazioni socioassistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente – in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (Cass. 2038\2023; Cass. 4752\2024, Cass. 33394\2024).
Su questo argomento merita di essere segnalata una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano (pubblicata il 13 ottobre 2025) che, confermando una decisione di primo grado del Tribunale di Monza, si è pronunciata in modo significativo su un caso diverso dall’Alzheimer, riguardante una persona costretta al ricovero in RSA in età ancora relativamente giovane (49 anni), perché in una condizione di gravissima non autosufficienza all’esito dell’uscita da uno stato vegetativo durato quattro anni dopo emorragia cerebrale. I due gradi di giudizio hanno accertato, anche tramite consulenza tecnica d’ufficio, che la paziente è affetta da plurime e gravi patologie invalidanti, a causa delle quali necessita di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato infermieristico e medico, senza le quali non potrebbe sopravvivere. Pertanto, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che, nel caso di specie, le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite se non congiuntamente all’attività di natura socioassistenziale, e ciò determina quella unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che produce l’integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale.
La pronuncia non si limita peraltro a richiamare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma fa altresì riferimento a quanto affermato da una sentenza del Consiglio di Stato (numero 1858 del 2019), che, nell’interpretazione della normativa sui LEA di cui al D.P.C.M. 12-1-2017, ha sottolineato come, con riferimento alle prestazioni di lungo assistenza estensive rivolte a persone non autosufficienti a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il termine previsto di 60 giorni può valere solo in linea generale, ma non può avere un carattere cogente, dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell’assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale.
La sentenza in commento ribadisce inoltre il principio, stabilito anche dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per il quale, una volta accertato che le prestazioni rese durante il ricovero in RSA sono da ritenersi ad elevata integrazione sanitaria, deve essere accolta la domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto stipulato con l’Ente gestore, nel punto in cui l’Amministratore di sostegno sia in rappresentanza della paziente, sia a titolo personale come garante, ha assunto l’obbligo di pagare la retta. Infatti, una volta accertato che dette prestazioni presentano le caratteristiche per essere incluse in quelle a totale carico del S.S.N., ne consegue la nullità, per difetto di causa, di un accordo di ricovero comportante l’impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione pecuniaria dovuta. Dalla declaratoria di nullità parziale del contratto deriva che i versamenti eseguiti in esecuzione dello stesso devono essere considerati indebiti, sicché vanno restituiti dall’Ente gestore che gli ha percepiti.
Questi importanti successi conseguiti attraverso azioni legali comunque lunghe (visto che si devono percorrere i 3 gradi di giudizio, fino alla Cassazione, con una durata media dai 7 ai 10 anni), lasciano tuttavia irrisolto il problema politico generale. Prendiamo come esempio la Lombardia, dove i posti letto accreditati e contrattualizzati con il sistema sanitario pubblico sono 57.286. Come detto prima, negli ultimi 7 anni soltanto 16 pazienti ricoverati presso RSA lombarde hanno ottenuto il riconoscimento dell’elevata integrazione sanitaria delle prestazioni di ricovero con oneri al 100% a carico del Servizio sanitario. In pratica soltanto 3 pazienti ogni 10.000 (ossia lo 0.03%), negli ultimi 7 anni, e soltanto a seguito di cause con tre gradi di giudizio, hanno ottenuto (quasi sempre post mortem) il riconoscimento di un diritto che, avrebbe dovuto invece essere garantito fin dall’inizio del ricovero, tramite apposita valutazione multidisciplinare della persona malata, dagli enti gestori delle RSA e dagli enti pubblici istituzionalmente preposti a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e il corretto finanziamento delle prestazioni di natura sanitaria (ossia ASL, in Lombardia ATS, e Regione).
E’ evidente che il problema non può essere risolto soltanto in via giurisdizionale. Il rischio è che le prossime scelte politiche legislative siano indirizzate ad eliminare la norma relativa all’elevata integrazione sanitaria se non si sviluppa una coscienza collettiva sensibile al problema e consapevole del valore universale ed egualitario del diritto alla salute così come concepito dalla nostra Costituzione.
Gli Enti gestori delle RSA, anziché condividere le politiche restrittive degli enti pubblici a danno dei malati e delle loro famiglie, dovrebbero fare pressione sui medesimi enti per garantire nei casi analizzati (dove sussistono gli estremi dell’elevata integrazione sanitaria) il 100% della copertura sanitaria dei ricoveri. Con particolare riguardo alla situazione della Lombardia, gli Enti gestori di RSA dovrebbero anche esigere per tutti gli altri ricoverati la copertura da parte del Fondo sanitario regionale del 50% del costo di ricovero come richiesto dai LEA, anziché, accontentarsi di una quota di copertura inferiore, in cambio della possibilità di avere mano libera per fare utili grazie alla determinazione di rette molto elevate.
Dal canto loro, le ASL (ATS in Lombardia) e le Regioni, dovrebbero investire risorse adeguate, come richiesto dai ricordati recenti orientamenti della Corte costituzionale, per programmare l’offerta sanitaria pubblica delle prestazioni in modo rispondente ai i bisogni di salute espressi dalla popolazione, compresa quella più fragile perché in condizioni di grave non autosufficienza.
A chiudere il cerchio, i Comuni dovrebbero predisporre regolamenti e delibere amministrative e destinare risorse adeguate, affinché, in coerenza con le finalità della normativa in materia ISEE, siano assicurati contributi economici proporzionati ai bisogni delle persone in relazione ai costi delle rette delle RSA (nei casi in cui non sia applicabile il principio dell’elevata integrazione sanitaria delle prestazioni).
In definitiva, e per concludere, l’idea guida delle vertenze legali (ed auspico anche politiche) potrebbe essere così sintetizzata: per tutelare il diritto alla salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività, alla luce di quanto stabilisce la nostra Costituzione, bisognerebbe sempre difendere e promuovere l’idea ispiratrice del Servizio sanitario pubblico, istituito, dopo anni di lotte politiche e sociali, con la legge 833 del 1978, ed oggetto purtroppo in questi ultimi trent’anni di continui attacchi, da parte dell’ideologia liberista e degli interessi dei capitali privati investiti nel settore assicurativo e della gestione delle strutture sanitarie e socio sanitarie. L’idea da difendere e promuovere è che, con il versamento delle tasse secondo il principio costituzionale di progressività, abbiamo il diritto, insieme agli altri consociati, di ricevere le prestazioni sanitarie, di cui abbiamo bisogno, senza subire discriminazioni in base all’età, alla tipologia, gravità e durata della malattia, o in base alle condizioni sociali ed economiche personali.
Luigi Lia è Cassazionista del Forum di Milano, attivo nelle reti di difesa del Diritto Costituzionale alla Salute