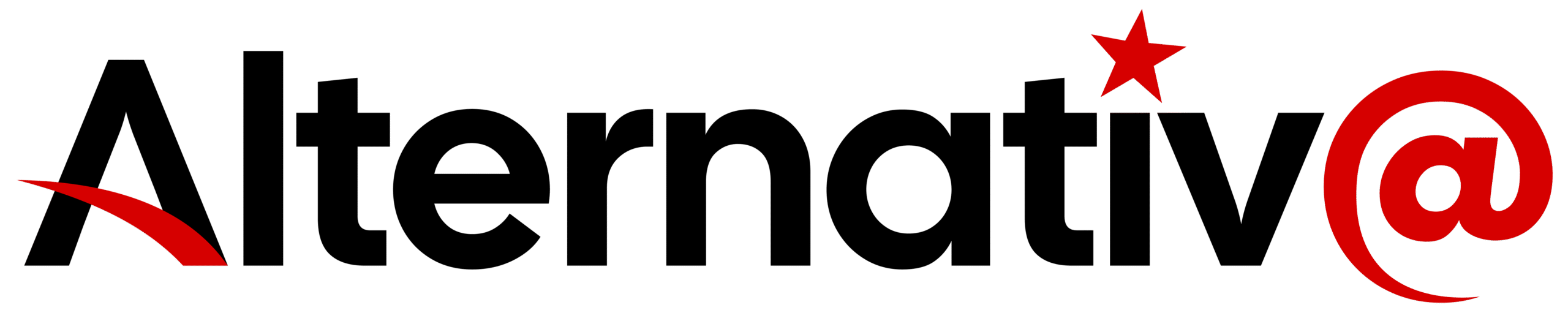Mimmo Porcaro, studioso indipendente dei problemi dei movimenti di classe e del socialismo
di Roberto Cabrino
Roberto Cabrino: Stiamo forse assistendo al tentativo di innescare un nuovo ciclo strategico in cui l’oggettività delle leggi di mercato passano in secondo piano e conta di più l’ordine politico che tenta di imporsi con la forza, per prendere ricchezza in modo arbitrario. Tutto pare vivere agevolmente dentro una democrazia svuotata mentre i nuovi fascismi sembrano marginali rispetto a quelli storici, di cui non riescono neanche a riproporre gli aspetti “sociali”. Che ne pensi?
Mimmo Porcaro: Oggi tutti parlano di “capitalismo politico”. In realtà il capitalismo ha sempre avuto bisogno dello stato e della politica, anche negli anni della (pseudo) globalizzazione in cui ci veniva raccontato che l’economia poteva funzionare “da sola” (mentre d’altra parte gli oppositori si raccontavamo che era la società a poter fare da sola). Oggi, è vero, anche in occidente c’è una decisa accentuazione dell’intervento di stato, sia per creare nuove fonti di profitto sia per reggere la concorrenza mondiale. Ma la cosa significativa è che lo stato che interviene è ormai occupato direttamente da alcune frazioni del capitalismo (in genere dalle big tech, dai grandi fondi e dall’industria militare) e quindi questo interventismo al di là delle apparenze non riporta in primo piano la politica, ma è una forma di potere diretto del grande capitale sulla società. Da qui il suo carattere reazionario che a mio avviso condurrà a una riduzione anche formale della democrazia e del pluralismo. Rispetto ai fascismi storici questa reazione non si presenta come occupazione dello stato da parte di un movimento politico alleato alla borghesia (e che a quest’ultima consente eventualmente la gestione di una parte degli apparati), ma appunto come governo diretto di quest’ultima. Da qui una sua possibile “difficoltà egemonica” sul medio periodo. D’altra parte l’attuale reazione ha però un carattere popolare analogo a quello fascista: si appoggia cioè a quella parte di popolo (oggi anche di proletariato) che vede in uno stato forte l’alleato contro altre frazioni delle classi subalterne (ieri gli operai socialisti, oggi gli immigrati ecc.), percepite come parassitarie e nemiche. E questo ci costringe a pensare non solo a come unire i “nostri”, ma anche a come dividere il fronte avverso.
A.D.: A dispetto di tutti i potenti dispositivi capitalisti messi a punto negli anni, la parte creativa della natura umana si è rimessa in moto a fronte dell’orrore genocidiario di Gaza. Quali sono secondo te le motivazioni, magari solo intuite, che stanno alla base della rottura del senso di impotenza durato anni, oltre naturalmente allo sdegno morale?
M.P.: La base delle proteste è indubbiamente morale. E qui sta la loro capacità di mobilitazione in un mondo per molti versi “postpolitico”. Tale base consente inoltre di intuire in qualche modo l’essenza della fase storica: in gioco ci sono direttamente la morte e la vita; si manifesta per evitare la morte altrui, ma si sa che domani si potrebbe trattare della nostra sopravvivenza. Ciò inizia a spezzare l’identificazione del capitalismo con un sistema che, bene o male e magari in maniera distorta, funziona comunque per consentire una vita decente a numerosissime persone. Inizia a formarsi invece un’identificazione del capitalismo imperialista con la morte. E’ un passaggio d’epoca. Inoltre, penso che nelle proteste si scarichi anche una energia di ribellione che è difficile esprimere in altri campi, perché tutte le lotte sociali sembrano intricate e confuse, condannate come sono a finire nel “porto delle nebbie” dei condizionamenti internazionali, dei vincoli europei, di un sistema politico chiuso, ecc. Qui invece non ci possono essere bizantinismi. O vita o morte.
A.D.: Il movimento che si è manifestato con determinazione e potenza nelle piazze in queste settimane ha davanti a sé un percorso tutto da costruire sul terreno dell’alternativa alla logica di gestione dell’esistente. Come pensi che si possa lavorare a costruire una nuova soggettività ricca, plurale, con le sue istituzioni senza cadere negli errori del passato?
M.P.: Credo sia meglio non illudersi: dai movimenti nascono spinte decisive, in essi emergono nuove generazioni di militanti ecc., ma non è da lì che nasce una politica. Con l’eccezione dei movimenti degli anni ’70 (che però erano intrinsecamente politici grazie alle organizzazioni e alle culture che li rendevano possibili: sindacati, nuova sinistra, ma anche sinistra storica), tutti quelli successivi hanno esercitato solamente una pressione esterna (a volte importante, a volte no) sui governi, mentre oggi si tratta non solo di conquistare i governi, ma addirittura di trasformare gli stati che altrimenti saranno solo strumenti della reazione di cui dicevo prima, rendendo vana qualunque esperienza governativa. Per fare ciò è necessaria la grande politica, che è fatta di progettualità storico-sociale e di intervento nella congiuntura concreta dei rapporti fra le classi, fra le classi e lo stato e fra quest’ultimo e lo spazio mondiale. Che è fatta, ripeto, della capacità di unire il nostro fronte e di sfondare le linee altrui. Tutte cose ben diverse dall’urlare una propria identità. Anche se quell’urlo è la premessa essenziale di qualunque politica popolare degna di questo nome. E’ dunque necessario costruire un pensiero strategico e una conseguente organizzazione. Ma si impongono due precisazioni. Prima di tutto è essenziale che nel processo siano coinvolte persone provenienti dai movimenti (ma anche persone che invece ad essi sono estranei e soffrono di altre contraddizioni): ciò per dare alla nuova organizzazione concretezza e aderenza al reale. In secondo luogo questa organizzazione (il “partito strategico” di cui abbiamo bisogno) dovrà essere costruita senza modelli precostituiti (partito di massa, movimento plurale, federazione di partiti ecc.): si tratta di tenere sempre a mente i compiti “alti” di cui sopra, ma di cercare nella realtà sociale quali siano le forme organizzative più adatte alla bisogna. Saranno i fatti a dirci cosa sarà più utile e possibile. “Camminare domandando” si sarebbe detto nel movimento altermondialista. Ma camminare, questa volta, sul sentiero di quel potere di stato, senza il quale non si può arrestare la tendenza all’impoverimento e alla guerra.